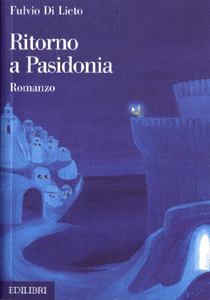
Ed. Edilibri, Milano – 2002 |

Ed. Il Calamaio, Roma – 2015 |
di Marina Sagramora
Introduzione dell’Autore
Parte I
Preludio a Manhattan
Musica e chiacchiere
Veduta con rovine
I nuovi trogloditi
Rifiuti e svendite
Babele, Babele
Musica sacra e profana
Acqua di mare e di cielo
Parte II
La frana
La legge chiude un occhio
Una nuova prova
Un sepolcro usurpato
Viaggi e motori
Un incontro decisivo
La pergamena
Una conferma a lungo attesa
Un addio
II testamento
Consiglio di famiglia
Parce sepultos
Le vie legali
Voci del giorno dopo
Nascita di un progetto
Arrivano i media
Spunta una lista
Si ricompatta la ciurma
Il regime si difende
La controffensiva
Il ritorno
Un amaro resoconto
Il regno del cuore
Parte III
Una conversione
L’anniversario
Un progetto politico
La rivelazione
Il Ducato rivive
PREFAZIONE
A volte il passato ritorna: a regolare conti sospesi, a suggellare destini incompiuti; ma anche, come nel caso di Andrea, il protagonista di questa vicenda, a recare insospettati doni: l’amore, cui aveva dovuto rinunciare emigrando, e la possibilità di aiutare i suoi conterranei a trovare la via d’uscita dal labirinto del degrado interiore ed esteriore nel quale sembravano essersi smarriti.
Pasidonia, una realtà immaginaria del Meridione d’Italia, diviene pertanto luogo emblematico della topografia politica e sociale del mondo, e i suoi abitanti repliche fedeli di tutte le creature umane alla perenne ricerca di un regno armonioso sempre vagheggiato e mai realizzato.
Incalzati dal ritmo degli eventi, in un’atmosfera di magia creata dal mirifico paesaggio e da indefinibili presenzeAndrea, Marcella e gli altri personaggi conducono il lettore alla scoperta di quel regno.
Romanzo, thriller, fiction o parabola, quale termine usare per definire questo libro? O forse potrebbe dirsi favola? Sí, una favola per adulti, visto che sono questi ad avere realmente bisogno di prospettive liberatorie, di incantamenti e di aperture al magico e al misterico.
Mentre i bambini hanno un ampio e variegato patrimonio favolistico cui attingere, gli adulti s’indirizzano normalmente a una narrativa, quella attuale, che non di rado finisce col riproporre le angosce e i grovigli esistenziali ai quali essi con la lettura vorrebbero sottrarsi.
Ecco quindi che l’Autore, che è essenzialmente un poeta, confeziona una favola per grandi provvista di tutti gli ingredienti capaci di affrancare il lettore da una realtà prosaica spesso degradata. E come è proprio delle favole, anche in questa è indicata una morale, che trova scaturigine dall’essenza immaginativa che la ispira: il mistero, l’insidia dei malvagi, la caduta dell’eroe, il suo riscatto e il recupero dell’armonia perduta.
Tornerà in tal senso utile definire la favola secondo il pensiero di Novalis, il quale non solo fu tra gli iniziatori del romanticismo tedesco, ma contribuí soprattutto, insieme a Ludwig Tieck e Clemens Brentano, alla riscoperta e alla rivalutazione dei Märchen, il patrimonio favolistico popolare germanico. Il ricorso alla favola o al contenuto fiabesco nel romanzo era volto per Novalis ai piú profondi intenti magico-misterici, come già aveva fatto Goethe con la sua Fiaba del Serpente verde e la bella Lilia.
Scrive Novalis nell’Allgemeines Brouillon: «La vera fiaba deve essere nello stesso tempo rappresentazione profetica – rappresentazione ideale – rappresentazione assolutamente necessaria. L’autentico poeta di fiabe è un veggente del futuro». Egli preconizzava un’epoca in cui non ci sarebbe stata piú differenza tra poesia e prosa, in quanto «la prosa piú alta, piú vera, è il poema lirico» e «un romanzo deve essere in tutto e per tutto poesia». Secondo l’autore di Enrico di Ofterdingen, l’unione di poesia e prosa avrebbe dato luogo alla vera fiaba: «Tutti i romanzi dove compare il vero amore sono fiabe – avvenimenti magici».
In Ritorno a Pasidonia la materia letteraria, in cui la prosa è compenetrata di poesia, vuole indicare il percorso che l’uomo attuale, confuso e fuorviato dai troppi segnali materialistici che riceve dalla realtà esteriore, deve compiere per giungere al magico castello dove risvegliare la Bella Addormentata della propria interiorità e riconquistare il Regno del cuore.
Marina Sagramora
INTRODUZIONE
Nel tempo sono state scritte e raccontate molte storie aventi come scenario di riferimento il Meridione d’Italia, e troppe forse ispirate ai problemi dell’emigrazione dalle regioni del Sud, con i laceranti distacchi e i difficili adattamenti in terre lontane, con la nostalgia degli sradicati, spesso motivo di sofferti ritorni.
Nello spirito di questo libro, vale però la pena ricordare una di queste storie di espatri, raccontata non da uno scrittore ma da un regista. Si fa riferimento a Pane e cioccolata, un buon film diretto da Franco Brusati e magistralmente interpretato da Nino Manfredi. A parte alcune topiche socio-politiche, i luoghi comuni etnici e una certa dose di retorica populista (l’epoca, il 1974, lo imponeva), il film mostra con occhio spietato, non esente da un lirismo forte e scabroso, le vicende di un emi-grato in Svizzera, e la sua parabola lavorativa che, iniziata bene, raggiunge un apice ottimale, ma poi inesorabilmente precipita verso il fallimento e conduce il protagonista allo spaesamento, inteso nel senso letterale del termine: lasciato con la misera valigia sulla linea ferroviaria alla frontiera tra Svizzera e Italia. Egli si sente respinto dal Paese dove ha invano tentato la fortuna, e allo stesso tempo angosciato dalla prospettiva di dover ritornare in quello da cui è dovuto andar via per bisogno, in quanto sa che ritroverà gli stessi problemi di sempre, ma soprattutto la solita gente rumorosa, scomposta, avvilita e resa prona da secolari soprusi e mortificazioni. A quel punto due sono le strade: l’alienazione in un limbo senza identità umana e anagrafica, o il ricorso alla fede, all’inter-vento provvidenziale. Il film non indica l’opzione scelta dall’interessato, lasciandone l’esito all’acume e alla fantasia degli spettatori.
Con diverse modalità, anche il protagonista di Ritorno a Pasidonia, Andrea, viene a trovarsi sulla linea di confine con una terra di nessuno. Non appartiene ormai piú agli Stati Uniti, Paese dove pure ha trovato la fortuna economica, ma al quale non si è mai legato sentimentalmente, e non riesce a reinserirsi in una società, quella dei suoi concittadini, che ha svenduto la propria anima per un edonismo di comodo e un profitto aleatorio, ottenuti a scapito dei valori morali. Un’anima che si nutriva di favole e miti, di metafisici umori, di devozione e rispetto per l’umano e il divino. È questa l’anima che cerca di ritrovare Andrea, partito da Pasidonia prima che il progresso materialistico ne stravolgesse la segreta armonia.
Egli si rende conto che non basta recuperare oggetti e reliquie per ritrovare quell’essenza perduta, e poiché nulla lo aiuta in tale opera di riacquisto, soprattutto i referenti politici e morali che avrebbero il còmpito di farlo, Andrea viene a trovarsi nella stessa condizione di inappartenenza dell’emigrato interpretato da Manfredi.
E cosí, come avviene nei casi disperati in cui la scelta è tra l’alienazione e la fede, dall’anima oppressa del protagonista erompe una muta invocazione al miracolo. Che non verrà negato, e sarà pegno di riscatto e redenzione per Andrea e per l’intera comunità di Pasidonia, dolente nell’interiorità benché gratificata in apparenza.
Questo libro tenta di raccontare la storia di tale miracolo.
PRELUDIO A MANHATTAN
Uscito dalla metropolitana, Andrea provò una sensazione liberatoria. In cima alla rampa di scale mobili lo avvolse una pallida luce pomeridiana, già carica di presagi autunnali. Raggiunse a passo lento Central Park. Una dominante azzurrina del cielo, quasi boreale, riverberava sugli specchi d’acqua del grande parco, sui laghi, laghetti e canali, fino a stingersi in toni grigi dove la massa dell’abitato urbano cedeva al plumbeo scorrere dell’Hudson solcato da battelli, rimorchiatori e chiatte da carico. Nelle scie dei natanti turbinavano uccelli dalle grandi ali, emettendo striduli richiami. A tratti, le sirene delle imbarcazioni, sopraffacendo quelle grida ossessive, rimestavano con le loro vibrazioni metalliche la cortina d’aria brumosa che gravava sul fiume e arrivavano fino a lui, lo riscuotevano dal torpore mentale, rimestandogli il sangue.
Autumn in New York!… Il motivo della canzone accese un gioco di risonanze gradevoli nella sua mente, e la voce di Sinatra si sovrappose al turbamento della memoria, ricamando la sua trama di calda naturalità su una immaginaria tessitura d’archi e l’assolo scrosciante di un pianoforte. Dopo l’incidente, gli capitava spesso di udire dentro di sé motivi di canzoni, giri armonici di melodie antiche, cosí all’improvviso, come se un golfo mistico nell’intima sfera del subconscio stesse lí pronto, con strumenti e interpreti, a imbastire suoni e canti. Ciò avveniva con tale forza di suggestione da catturarlo, costringendolo a canticchiarli, magari sottovoce, in un sussurro, o semplicemente a mugolarli se stava in compagnia di altre persone. Il passato in forma sonora irrompeva con prepotenza evocativa nella sua mente. Suggestioni consolatorie, lampi di luce benefica nel buio pesto della sua anima.
Mancava dal Central Park da anni, cioè erano anni che non vi entrava a passeggiare, o a fare una gita in barca, o ad ascoltare i concerti estivi, o a vedere i pattinatori sul ghiaccio durante l’inverno. Per la verità, la stessa Manhattan gli era quasi estranea, se non per fugaci attraversamenti in auto con sua moglie, diretti ai vari incontri di lavoro, per gli impegni di relazioni pubbliche, o per visite a clienti e fornitori, o per recarsi negli studi legali e notarili per contratti commerciali o di acquisizione di altri ristoranti e locali da annettere alla già vasta rete di esercizi di cui la famiglia di sua moglie Elena era proprietaria.
Tutti quelli che contavano volevano stare a Manhattan, o almeno avervi un recapito d’affari. Eppure, scoccate le cinque del pomeriggio, tutti se ne volevano andare, quasi fuggirne, come se nell’intrico di palazzi e grattacieli la notte un mostro divoratore potesse uscire a caccia di esseri umani. Forse, a ben pensarci, un simile mostro c’era davvero, magari non in forma fisica, e si pasceva degli egoismi umani, delle loro manie di gigantismo e possesso materiale.
Per questo, ma era solo una sua suggestione, sentiva di essere stato, per tutti gli anni del suo soggiorno americano, un estraneo a quella vita frenetica e sorda ad ogni palpito di umanistica pietà, di cristiana misericordia. Forse in America, ora che ci pensava, non c’era mai veramente stato e non aveva effettivamente partecipato a quel vivere trafelato, col paraocchi e la frusta, per acquisire potere e successo. Il punto di fuga di tutto quel correre e affannarsi era il dollaro, la rotonda divinità esigente dagli adepti un culto esclusivo, una cieca devozione da zeloti.
Si fermò in un vialetto del parco, dove uno strano albero si piegava verso la superficie paludosa dell’acqua con la sua sagoma contorta e ruvida, irta di rade foglie innestate a rami cresciuti in anarchia. Gabbiani in transito dall’estuario si riposavano sulla breve lingua di terra fangosa che dal prato avanzava nell’acqua. Si sedette su una delle panchine di legno allineate a intervalli regolari lungo il sentiero asfaltato che costeggiava il laghetto di Park Lane. Due maratoneti, un lui e una lei, non piú giovani, gli passarono davanti. Per un attimo s’interposero saltellando tra il suo punto di osservazione e lo specchio brunito dell’acqua. La donna era minuta, leggera e magra, con i capelli trattenuti da una retina annodata con due stringhe dietro la nuca. L’uomo aveva gambe magre, con i polpacci arrossati per lo sforzo, i capelli folti, color sale e pepe, che si ostinavano a coprirgli la fronte a ogni balzo e che lui, con uno scatto del collo, rimandava indietro. Da come i due si parlavano ansimando nella cadenza della corsa, dagli sguardi che si scambiarono rapidi passandogli davanti, emanava un che di consueto e tranquillo, fiducioso nell’altro, e Andrea poté stabilire che fossero marito e moglie. Una coppia fatta di intese inespresse ma solide, collaudate e convinte, in qualche modo complici. La fiducia senza remore nei sentimenti e pensieri dell’altro, il poter accedere in qualunque momento e condizione animica e mentale nello spazio vitale e sentimentale del partner, faceva sí che l’accostarsi fisico, la simbiosi fisiologica, lo scambio emozionale avvenissero in maniera spontanea, come toccando un oggetto che ti appartiene per lungo uso, che sai che è sempre lí, disponibile, dove lo avevi lasciato, nel posto dove ti aspetti di trovarlo, a occhi chiusi, in automatismo tattile, e che sai con certezza di poterlo ritrovare l’indomani, e nei tanti giorni da vivere insieme. A meno che…
L’immagine di sua moglie irruppe di colpo nella sua memoria, accompagnata da quel sorriso leale che le illuminava il viso. Una luminosità sobria e sana, dove la tenerezza è sottintesa, fa parte del segreto e del mistero di una persona. Come certe spezie fanno la qualità indefinibile di una pietanza e sono l’arte specifica del grande cuoco, la sua specialità mai rivelata, e la cui combinazione è forse fortuita, frutto di un casuale evento combinatorio, la ‘scoperta’ da cui dipende la maggior parte delle invenzioni e formule mirabolanti della scienza umana. Elena aveva nutrito la sua vita di quel sorriso forte e rassicurante, pervaso di una occulta, vibrante dolcezza.
Fino a quella sera di gennaio, quando la composta affabilità di quel sorriso, l’energia solare che diffondeva intorno sulle persone e sulle cose, si erano spente in uno stridore di ruote, nell’urto di parti metalliche che orribilmente si disgregavano, oppure si interpenetravano collidendo, fondendosi in un groviglio informe, prima della immane fiammata, un flash infernale che aveva invaso l’anima e la mente. E subito dopo, lo strappo violento dalla consapevolezza, lo svincolamento dai sensi per sprofondare nel buio e nel silenzio. Un territorio alieno e infido dal quale, nessuno poteva dire come, lui era riuscito a riemergere dopo settimane. Ma lei, la forte donna piena di vita e di speranze, si era persa in quelle terre desolate, risucchiata nel vortice dove la materia si disfa ritornando al nulla inerte, inanimato della polvere.ù
I due maratoneti gli ripassarono davanti, questa volta nella giusta luce, e poté a vederli meglio. La donna aveva un viso dolce e lentigginoso, una bocca piccola e sensibile, che il sudore, scivolando dalla fronte, imperlava di gocce. Rise a una parola di lui, piegando il capo con uno scarto aggraziato. Altre persone, singole o accompagnate, passeggiavano o attraversavano i vialetti del parco, ma quei due, agli occhi di Andrea, facevano la storia. Erano qualcosa di unico, creavano l’happening della coppia unita da un’intesa non solo esteriore. Tra quei due che correvano, girando intorno al laghetto, sembrava esserci un’amicizia che era consonanza, sintonia, che accordava i loro gesti, uniformando persino i loro pensieri.
L’amicizia, rifletteva ora Andrea, seguendo con lo sguardo la coppia che si allontanava lungo il sentiero asfaltato, sollevandosi in piccoli scatti cadenzati, veniva prima dell’amore, e lo fortificava, lo garantiva contro ogni imprevisto o smarrimento. È, si diceva, un fluido possente che porta invincibilmente un essere verso un altro, facendo scegliere tra mille una persona, per porgerle favori e doni, gratuitamente, senza calcolo. Cosí era stato con Elena. Ricordava esattamente come era iniziata la loro amicizia.
«Lei è italiano, vero?» cosí lo aveva apostrofato quel giorno di tanti anni prima, alla pompa di benzina dove Andrea lavorava, il suo primo impiego da immigrato. Lo avevano colpito due particolari: la gentilezza di lei che sporgeva il viso aperto e cordiale dal finestrino dell’auto, e il fatto che, rivolgendosi a lui in italiano, gli desse del lei. Che si esprimesse in italiano non lo aveva stupito piú di tanto. In quella zona del New Jersey sembrava di stare in una qualunque cittadina del Bel Paese, per quanti dialetti venivano masticati intercalandoli all’inglese, pronunciato alla maniera yankee. Ma il “lei” voleva dire che quella donna gentile vedeva oltre la tuta da benzinaio che lui indossava, e non si sarebbe limitata a chiedergli di fare il pieno o lavarle la vettura. No, quella donna, anzi ragazza, dai capelli chiari, l’aria gioviale e lo sguardo amichevole, con quella domanda cortese gli stava semplicemente proponendo di entrare a far parte della vita americana con altre prospettive e credenziali.
«Perché non viene a trovarmi al ristorante?» aveva aggiunto subito dopo, porgendogli un cartoncino. Poi era ripartita, salutandolo ancora con la mano e sorridendogli, prima di immettersi con scioltezza nel traffico
dell’avenue. Il biglietto pubblicitario diceva “At Dante’s. Best Italian cuisine”. Sotto la scritta, il profilo del sommo poeta coronato di alloro, il naso aquilino. Aveva scoperto poi che una binomia casuale giustificava il nome del ristorante della ragazza sorridente e cordiale.
«Io sono Dante… Dante Zanon» si era presentato il padre di lei, stringendogli con vigore la mano. E poi seguitando, in tono deciso: «Mia figlia mi ha detto che vuoi…».
Elena si era subito intromessa: «Papà – aveva detto in tono di bonario rimprovero – ricordati!».
E l’uomo: «Ah, già – si era corretto, sorridendo con impaccio – che vuole lavorare qui con noi». E fece tracciare alla mano robusta un largo circolo che abbracciò tutto il vasto locale.
Cosí era cominciata la sua vita in America, quella vera, con una identità e un progetto validi. Aveva appena vent’anni, allora, Elena uno di meno. Si erano sposati un anno dopo, e lui era entrato di diritto nel clan dei veneti, di cui facevano parte tutti i discendenti degli immigrati dalle province del Nordest nei primi anni del Novecento: Belluno, Treviso, Udine, Gorizia. Tra loro molti gelatai e pasticcieri, come il padre di Elena, che avevano ripreso il loro mestiere negli States, ampliandolo ai ristoranti e alle groceries, specie di empori gastronomici dove si vendevano tutti i prodotti alimentari italiani, sia crudi che cotti.
Del clan dei veneti faceva parte anche il padre del dottor Vittorio Malcotti, col quale Andrea aveva l’appuntamento quel pomeriggio di primo autunno. Il dottor Malcotti era nato in America, a New York, come la moglie di Andrea. Appartenevano alla generazione degli integrati, cosí amavano definirli nella comunità italiana del New Jersey, e i vecchi, come papà Dante, non vedevano di buon occhio la loro smania di essere piú americani del normale, come lui diceva sempre, “piú realisti del re”.
Ma se quella critica mal si riferiva a sua figlia Elena – che non aveva mai perduto i suoi legami animici con gli usi e i costumi della sua famiglia e la sua terra di origine, e che parlava quindi con spigliatezza il dialetto veneto – calzava a pennello al dottor Malcotti, figlio di uno dei piú accaniti tradizionalisti del clan dei veneti. Sconfessando lo zelo patriottico di suo padre, il Malcotti figlio si era laureato alla Columbia University con il massimo dei voti. Usando i soldi della famiglia, e anche le proprie capacità imprenditoriali e professionali, aveva costruito il Rosehill Sanitarium a Long Island. Era lí, in quella clinica raffinata e costosa, che Andrea aveva recuperato dopo l’incidente.
Ma il Sanitarium di Rosehill, che il Malcotti integrato, in tono con la sua ricercatezza lessicale, sontuosamente definiva “Centro di rigenerazione fisio-endotimica”, non era la sola vittoria riportata dal brillante e ambizioso specialista sul cammino della sua full integration nella società americana. Sempre sfruttando le amicizie altolocate con i facoltosi pazienti della clinica, che spesso vi venivano dirottati dalla frequentazione del celeberrimo ritrovo di specialità marinare di proprietà di Malcotti padre, il figliolo dottore era riuscito a trasformare il suo cognome in Malcothy, e quindi era diventato per tutti, colleghi e pazienti, Vic Malcothy. Suo padre Marco non gli aveva voluto parlare per mesi, ma poi, osservando come suo figlio procedeva a tutto vapore sulla strada del successo, si era rassegnato, anche perché era diventato uno dei piú assidui pazienti di Rosehill. «Almeno – diceva ai suoi coetanei e compaesani per giustificarsi – sto nel mio».
E cosí quel nome, Vic Malcothy, risuonava ormai con enfasi nei salotti della politica, degli affari e della finanza, nelle sale delle convention, veniva citato sulle riviste mediche, e finanche sui rotocalchi mondani, con l’immagine patinata e seriosa di un luminare della scienza medica che dall’alto del suo immane sapere si chinava con olimpica degnazione sul dolore e sull’angoscia dell’umanità toccata dal male in tutte le sue forme ed espressioni: fisiche, psichiche, anatomiche ed estetiche.
E guai se in qualche riunione di famiglia, o durante una delle tante commemorazioni e feste di connazionali, il vecchio Marco Malcotti si lasciava andare alle reminiscenze nostalgiche della sua terra di origine, rivelando le radici autenticamente paesane e rurali dei suoi antenati, con le usanze rusticane da essi praticate. Se il celeberrimo figlio era nelle vicinanze, si sentiva riprendere: «Please, pa’, don’t become the usual Venetian ciacolon!».
E il padre, volgendosi intorno e allargando le braccia: «Bah, me toca tàser!», e si scusava impacciato con tutti quelli che assistevano alla scena, specie se erano italo-americani. Ma a chi lo conosceva bene non poteva sfuggire il tenue sorriso di compiacimento che Malcotti padre aveva appena abbozzato perché il figlio, illustre e integrato, nello sfoggio del suo impeccabile inglese, non aveva potuto evitare di usare un termine che piú veneto di cosí non si sentiva neppure in una baruffa tra popolane chiozzotte.
Poco prima delle cinque, mentre il sole si avviava a tramontare incupendo l’atmosfera del parco, Andrea suonò alla porta del lussuoso condominio di Park Lane, dove il dottor Malcothy aveva il suo studio. Pochi a New York potevano permettersi una ubicazione milionaria di quella fatta, considerando che un metro quadro a Manhattan, persino nelle strade piú defilate e squallide, quotava cifre astronomiche, se mai si riuscisse a trovare uno spazio disponibile. Anche lo studio in cui ora una giovane infermiera bionda, gonne corte, passo felpato e voce soft, lo stava pilotando verso la sala d’attesa, la diceva lunga sulla capacità strategica messa in atto da Vittorio Malcotti per realizzare la sua evoluzione semantica, e non solo, in Vic Malcothy. Titoli di studio, diplomi, benemerenze, onorificenze tappezzavano letteralmente i muri della sala di attesa, ed erano stati preceduti già nell’anticamera e lungo il corridoio da foto che ritraevano il dottore insieme a grosse personalità della politica e dell’amministrazione municipale della Grande Mela, in pose ufficiali o di semplice rapporto informale, segno di rispetto e di amicizia. E poi le prolusioni ai congressi, le presentazioni delle innumerevoli fatiche letterarie del dottore, insigne saggista nel campo della ricerca e della terapeutica. Insomma, Vic Malcothy era riuscito in quello che nel romanzo e nel film “Il Padrino” era stato il sogno di Vito e Michael Corleone: la piena, legittima integrazione nell’alta società americana.
L’infermiera era scivolata via felpata sulla costosa moquette color malva pastello, eterea, accordandogli un vezzo di sorriso ninfale, e con le dita lunghe, affusolate, gli aveva indicato il sofà: «Il dottore la riceverà subito…» aveva annunciato, come parlando da una soffice nuvola. Elargiva tutta la vellutata efficienza che giustificava le salatissime parcelle di Malcothy.
Andrea lasciò scorrere lo sguardo prima sugli innumerevoli attestati e diplomi che tappezzavano le pareti della saletta, ma poi tutta quella esibizione di pedigree professionali e mondani lo stancò, e lo spostò allora sulla grande finestra panoramica che prendeva quasi tutto lo sviluppo della parete. Grazie all’effetto grandangolare della vetrata, tutta la stanza sembrava sospesa sul vuoto del viale che separava il prospetto dei palazzi e grattacieli dal verde di Central Park. Uno strano effetto ottico faceva sí che gli alberi, i vialetti e lo stagno dove si era fermato poco prima gli sembrassero, nonostante la maggiore distanza, piú vicini di quanto gli erano apparsi standoci da presso. Poteva distinguere nettamente i frequentatori del parco, gli alberi piegati verso la superficie tranquilla del lago artificiale, con gli uccelli che vi scivolavano dopo una picchiata, e vi tracciavano solchi di spuma biancastra ribollente. I due maratoneti non c’erano piú. Li aveva ripresi la città col suo fervore nevrotico, la sua febbrile voracità, e quella loro intesa pacata e tenera avrebbe dovuto lottare corpo a corpo con lo stress, la smania degli inarrivabili traguardi, se voleva, come verosimilmente voleva, mantenersi intatta e sopravvivere. Si era alzato il vento e un turbinio di foglie screziate si sollevò dalle cime degli alberi, volteggiò nell’aria insieme agli uccelli spaventati, si spense a pioggia finendo in mulinelli nello stagno.
«Bello, vero?» commentò con enfasi Vic Malcothy. Andrea rigirandosi lo vide incorniciato dal sontuoso telaio della porta, un’icona perfetta dell’omologazione americana, con i capelli corti tagliati alla forbice, brizzolati quanto occorreva per denotare maturità e successo accademico, una faccia cotta dal sole dei campi da golf e da tennis, sulla quale brillavano gli occhialetti con montature al titanio brunito, una esuberante cordialità che emanava da tutto il suo apparato psicofisico e avviluppava oggetti e persone intorno.
Quel totem da positive man si portò con fare spigliato presso il sofà dove era seduto Andrea, attese che si alzasse e gli strinse la mano con vigore, sorridendo. Poi il suo sguardo illuminato da una trascinante euforia si spostò dal visitatore alla scenografia urbana che si delineava oltre la vetrata della finestra.
«Sí – esclamò deciso – una vista unica, non trova?». Attese invano un commento di Andrea, alquanto frastornato. Si affrettò ad aggiungere: «Direi straordinaria… ne conviene?».
A quel punto, l’interpellato si sentí in dovere di rispondere: «Effettivamente, una vista unica…» e si accostò alla vetrata dove già si trovava Malcothy, che guardava fuori visibilmente compiaciuto.
Dopo una breve pausa, il dottore disse con orgoglio: «Tutto quello che vede è solo grazie al vetro stroboscopico di questa finestra – spiegò annuendo piú volte – un materiale unico… Venga intanto nel mio studio, le spiegherò meglio». E lo precedette svelto lungo il breve corridoio interno.
La solerte infermiera era sulla soglia, spinse con garbo la porta, anche lei dispensando un largo sorriso. Poi si eclissò, in un fruscio di calze bianche di seta, dopo aver richiuso.
«Si tratta, come le stavo spiegando – riprese a dire Malcothy dopo essersi installato dietro la sua scrivania e facendo cenno ad Andrea di accomodarsi di fronte a lui – di un vetro molto speciale, cioè, per essere precisi, piú che di vetro dovremmo parlare di cristallo multifocale prismatico, prodotto dalla ditta Fairchild, quello dei cantieri navali, sa?». Di nuovo attese un cenno di assenso che non venne. Seguitò: «Un cristallo cosí lo montano su tutte le vetrate dei ponti di comando delle navi da crociera dell’ultima generazione. Può reggere a ondate di mare forza sette, e inoltre consente una visibilità a 180 gradi, quanto mai indispensabile nelle manovre di attracco nei porti tropicali, specie dei Carabi. L’armatore tra le altre cose ha una villa nelle isole Vergini, e pensi che ha fatto mettere questi vetri speciali a tutte le finestre della sua residenza, e anche delle ville dei suoi amici, compresa la mia, che sorge a poca distanza da quella di Fairchild, sulla costa occidentale, la migliore per la navigazione e il soggiorno. È la piú riparata dai venti dell’oceano, e davanti alla spiaggia si estende la barriera corallina, quindi niente squali o roba del genere… Mi capisce?».
Sí, Andrea capiva, e annuí con quanta piú cortesia e immedesimazione poteva.
Il dottore seguitò con fervore: «Ebbene, come le stavo dicendo, questo speciale cristallo stroboscopico è stato un regalo che il grande armatore Fairchild ha voluto farmi in via del tutto riservata… non è un prodotto in commercio».
Andrea tentò di sgranare gli occhi per gratificare l’entusiasmo di Malcothy, ma tutto quello che riuscí ad abbozzare fu una specie di corrugamento della fronte e uno spasmo agli angoli della bocca, come un sorriso inebetito.
Il dottore non ci fece caso, e proseguí sciolto col panegirico sul cristallo dell’armatore: «Lei deve sapere, caro De Marinis – il tono si fece confidenziale – che io al Fairchild ho recuperato la figlia, l’ho presa letteralmente per i capelli, tirandola fuori da una gravissima forma di anoressia, giudicata irreversibile dagli altri specialisti che l’avevano avuta in cura… – indicò sussiegoso la vetrata – ed ecco perché questo cristallo è stato donato al salvatore di sua figlia, l’unica figlia… Il maschio morí in un incidente di pesca, qualche anno fa…». L’euforia di Vic Malcothy venne offuscata da una nube di commiserazione, ma lo spirito mondano del dottore fece presto a diradarla con una battuta di circostanza: «Certo, lí alle Isole Vergini le grandi vetrate della villa di Fairchild, e in parte, modestamente, anche della mia, davano direttamente sulla laguna. Sembrava di avere il mare proprio dentro casa, mentre qui dobbiamo contentarci dei laghetti acquitrinosi del Central Park, una natura addomesticata. Al meglio, qui, se il tempo è buono come oggi, si può riuscire a scorgere anche il fiume e lo skyline della città con i suoi grattacieli!…».
Pigiò un bottone sulla tastiera che aveva davanti sulla scrivania: «Miss Baxter – disse rivolto all’apparecchio interfono, animato da un leggero fruscío – nessuna chiamata per mezz’ora, la prego!».
E cosí il dottor Malcothy, pensò Andrea, con quella richiesta alla sofisticata segretaria tuttofare, gli aveva fatto capire, con raffinata strategia opportunistica, che il loro colloquio sarebbe durato non piú di trenta minuti. E del resto, si disse, non avrebbe desiderato stare piú a lungo in compagnia di quel dottore stroboscopicamente eccessivo.
«Allora – riprese in tono gioviale Malcothy – l’uccello è pronto al volo!».
«Sí, domattina alle nove, dal Kennedy» confermò Andrea, non senza una certa commozione nella voce.
«Come si sente?» da dietro gli occhialetti al titanio, le pupille del medico lo stavano fissando con professionale indiscrezione.
«Credo bene – fu la risposta di Andrea, dopo una breve esitazione – penso di essere a posto adesso… anche e soprattutto grazie a lei, dottore!».
L’affermazione di quel proclamato benessere aleggiò proditoria, anzi temeraria, nella stanza. Andrea ne smaltí l’imbarazzo fissando il parquet, certamente anche quello di qualche pregiatissimo legno arrivato nello studio tramite un altolocato paziente, quasi certamente il piú grosso importatore di mogano, tek e palissandro di tutti gli States. Meno di questo non sarebbe bastato a chicchessia per entrare a far parte del clan esclusivo del dottor Vic Malcothy. Andrea ci era riuscito in virtú della sua aggregazione alla consorteria veneta, e del ruolo che vi ricopriva papà Zanon.
Scambiando la commozione di Andrea per apprensione riguardo alla sua appena trascorsa malattia, e temendo che il paziente volesse lasciarsi andare alla disamina del suo stato depressivo, il che avrebbe comportato uno sforamento dell’orario riservato alla visita, Malcothy smise di sorridere e assunse un’aria grave, seppure cordiale, ma dal piglio sbrigativo: «Vede, signor De Marinis, la sua non è stata una malattia mentale, ma una semplice patologia sentimentale, una nevrosi di angoscia, tutto qua. Lei è del tutto normale dal punto di vista psichico, come chiunque altro. Superato il trauma dell’incidente e il senso di colpa ad esso collegato, non ci sono residui nuclei depressivi profondi da rimuovere, se non il ricordo. E anche questa scoria andrà via con il tempo e con la lontananza dai luoghi in cui il trauma ha avuto origine. Mi creda…» e la sua mano sembrò volersi tendere attraverso il ripiano della scrivania per raggiungere quella di Andrea, ma a metà strada si trattenne.
Era sinceramente coinvolto, il dottore. Ma come avrebbe potuto Andrea spiegargli che, mentale o sentimentale che fosse, il dolore che sentiva dentro era un immenso grumo di pianto rappreso, un nodo amaro e terribile di cui stentava a liberarsi?
L’altro parve leggergli nel pensiero: «Il tempo, signor De Marinis, come le dicevo, solo il tempo sarà la medicina giusta…». Si interruppe e sollevò la cartellina che aveva dinanzi. Soggiunse: «Comunque, ecco qui l’indirizzo del dottor Fausto Martello a Napoli, un eminente neurologo e un mio caro e fidato amico. Un vero luminare nel suo campo».
Sorrise, mentre spingeva il foglietto attraverso il ripiano. Attese che Andrea lo riponesse nel portafoglio. Poi riprese, in tono piú distensivo: «Ma sono certo che non ne avrà bisogno, vedrà. Cambiando ambiente e contatti umani, tutto quello che ha passato le sembrerà solo un sogno». Si alzò dalla sua poltrona e scuotendo la testa con un movimento regolare andò presso la finestra. Qui, un po’ guardando giú nel parco, un po’ rivolgendosi ad Andrea, disse, come se monologasse: «Strano meccanismo la mente umana, signor De Marinis. Noi abbiamo scandagliato a lungo la sua, durante quella, diciamo, malattia, anche durante le sedute di ipnosi regressive, secondo il metodo del mio illustre collega Farrel, e siamo risaliti molto indietro nella sua vicenda. E quel suo parlare in maniera strana, come in una lingua antica, un italiano medievale… Cosí diagnosticò il dottor Aspesi, che seguiva e interpretava le sue regressioni. Medievale, sí, definì proprio cosí lo strano idioma nel quale rispondeva alle nostre domande, o semplicemente discorreva con immaginari personaggi che evidentemente lei vedeva nella sua ipnosi…».
«Non ricordo assolutamente nulla, dottore!» replicò Andrea.
«E deve essere cosí, caro mio, guai se lei ricordasse!».
«Medievale… – ripeté Andrea perplesso – ma io non ho studiato altro che un po’ di latino alle medie, naturalmente l’italiano, e qui l’inglese… tutto, fuorché l’italiano medievale, a meno che il dialetto della mia terra di origine, il napoletano, possa venir scambiato per italiano medievale…».
Risero entrambi.
«Non lo credo proprio» disse faceto Malcothy, sollevando le braccia in segno di resa. «Misteri della psiche umana – concluse sbrigativo – come le dicevo poc’anzi».
Si salutarono presso la vetrata, due sagome ossequiose rilevate contro l’ultimo chiarore che veniva dal crepuscolo sul fiume, rosseggiante oltre la massa brumosa degli alberi. L’infermiera lo accompagnò alla porta, frusciando nella sua inarrivabile efficienza soft.
I figli erano commossi, specialmente la ragazza, Jane. «Riposati, pa’ – disse abbracciandolo – e divertiti. Me lo prometti?». La forzata severità del tono non riusciva a nascondere il groppo di pianto che le serrava la gola.
E il figlio, Andrew junior, che voleva apparire piú forte, lo esortò: «Attento alle belle ragazze di Pasidonia, eh?». E lo strinse forte e a lungo, quasi a trasmettergli quell’energia che in lui straripava e in suo padre si era come spenta. «La vita continua, pa’ – aggiunse guardandolo intensamente negli occhi – non possiamo fermarci a rimpiangere quello che è passato. Pensiamo al futuro!». Lo scosse ancora un paio di volte.
Jane lo riprese tra le braccia: «Soprattutto, non farti una colpa di nulla, e non preoccuparti per noi. Penseremo noi a mandare avanti tutto, col nonno e gli altri. La De Marinis Catering darà sempre il meglio».
«Happy landings, pa’!» augurò Andrew e gli prese la mano per stringerla.
Jane lo accarezzò con dolcezza e Andrea ebbe una stretta al cuore perché, senza volerlo, sua figlia aveva fatto lo stesso gesto di Elena, uguale, quando lo salutava mentre usciva o partiva senza di lei. E ora lui stava partendo, e lei non lo accompagnava. Non piú.
I due figli lo abbracciarono insieme, accompagnandolo cosí fino al banco del check-in. Attesero oltre il tornello della dogana, e quando lui si rigirò per l’ultima volta a salutarli, agitando la mano nell’aria, risposero imitando il suo gesto. Jane socchiuse le labbra sottili in un cenno di sorriso. Andrew rimase impassibile. Poi girò di scatto le spalle. Li vide sparire tra la folla che gremiva la sala delle partenze, due puntini scuri persi tra le onde grigie dell’umanità che si agitava, partiva per luoghi noti o ignoti, sbarcava da tormentati viaggi, tornava da fugaci evasioni in terre di cui mai avrebbe penetrato misteri e segreti. E lui che ora partiva, su quali approdi avrebbe terminato il suo volo?
Il grande aereo, prima di lanciarsi nel vuoto dell’oceano, virò sorvolando la città che un sole pallido illuminava. Una città irta di picche e lance di vetro e cemento, una città armata, in perenne allerta. Piú di qualunque altra al mondo, New York era un luogo che meglio rappresentava le nevrosi dell’uomo civilizzato, un campionario di tutti i desideri e di ogni frustrazione. Forse, a ben rifletterci, lui non le era mai veramente appartenuto, e non rimpiangeva nulla di essa, a parte i figli che aveva appena stretto a sé, e che erano il suo cuore e il suo sangue, lo stesso appartenuto per la metà genetica a sua moglie Elena. Non era appartenuto che a lei, e un po’ al clan di papà Zanon e dei Malcotti. E anche loro, a ben pensarci, quanto appartenevano alla società del business spregiudicato, dei grossi affari, del cinico giro finanziario? Forse lui e loro, lasciando il proprio paese per adottarne un altro, si erano staccati dalla corda di sicurezza, e piú che vivere avevano fluttuato in una sorta di limbo sociale e culturale dove giungevano echi del mondo vero americano, e rari privilegi, come relitti sbarcati da un mare tumultuoso e infido.
E lui, Andrea De Marinis, a quale mondo realmente apparteneva? Riascoltò nella mente le parole del dottore: «Una lingua antica, medievale…» e si domandava, mentre il gigantesco aereo forava le nubi e raggiungeva la quota di crociera in un cielo aperto, turchino e pulito, nella regione neutrale dello spazio senza riferimenti e definizioni territoriali, quanto antica fosse la sua anima, se avesse cioè mai vissuto realmente la vita, quella a lui destinata, e non quella imposta dallo sradicamento forzato.
Sotto, in basso, l’oceano Atlantico non aveva una risposta al suo quesito, come non l’aveva mai avuta per tutti quelli che lo avevano attraversato. Ogni uomo ha la sua storia.
SPUNTA UNA LISTA
I giorni che seguirono la visita della troupe di Pallanza portarono frenetiche novità. Gli articoli apparsi sui quotidiani del gruppo Baratti, il grande reportage sulla rivista settimanale «Scoop» e infine la proiezione del filmato ripreso nella cripta e nella Torre, diffuso dalla rete televisiva su tutto il territorio nazionale, ebbero, come era da aspettarsi, un forte impatto sulla pubblica opinione.
Il luogo del ritrovamento divenne quindi meta di pellegrinaggi variamente compositi: gente di tutti i ceti e provenienze iniziava ad affluire alle prime luci del giorno. Le visite non terminavano che a sera inoltrata, e alcuni manifestavano addirittura l’intenzione, sull’esempio di quanto avviene nei luoghi di venerazione religiosa, di pernottare accampati alla meglio lungo i vialetti del giardino, e magari anche sugli scogli sottostanti. Era una folla enorme, ma composta e commossa. Anche se a volte manifestava scetticismo e diffidenza, rimaneva sempre rispettosa mentre osservava le spoglie di Theodoro e i reperti esposti nelle bacheche della Torre. Qualcuno chiedeva anche di incontrare il padrone di casa, protagonista della strabiliante scoperta. Ci furono alcuni che, piú ardimentosi degli altri, pensarono bene di venire alla grotta via mare, a bordo di canotti, barchette e gommoni, che venivano ormeggiati alla meglio presso la scogliera. Da lí i pellegrini del mare si arrampicavano con grande rischio, sfidando le incerte balze calcaree, la fitta macchia, o la muraglia impenetrabile dei fichi d’India. La curiosità vinceva anche la paura di finire in mare, o infilzati agli aculei dei cactus.
Osservando tutto quel frenetico movimento, Andrea non poteva fare a meno di considerare come quel morto, lasciato per secoli nell’oblio della caverna marina, ora si prendesse la sua bella rivincita, richiamando tanta gente da fare concorrenza al santuario dei martiri Cosma e Damiano su a Poggioameno.
La gente arrivava, per mare o per terra, davanti allo speco dove Ferdinando, vigile improvvisato, dirigeva la corrente dei visitatori, in modo che da una parte entrasse, seguisse un percorso stabilito all’interno, sostasse pochi attimi nei pressi della nicchia con i resti del Duca e poi velocemente e in silenzio defluisse seguendo una traiettoria opposta a quella di entrata, cosí da non incrociare quelli che dovevano ancora effettuare la visita.
Andrea, dall’alto del terrazzo, controllava che tutto l’insieme procedesse per il meglio. A tratti veniva assalito da un interrogativo angoscioso, che subito ricacciava indietro: sarebbero riusciti, lui e gli altri imbarcatisi nell’operazione Theodoro, a cavalcare l’imprevedibile tigre della folla che ora, sotto la spinta della curiosità, del fervore o della devozione, sfilava disciplinata e calma ma che in un qualsiasi momento, sollecitata da opposti imbonimenti, poteva sbalzarli dalla groppa e divorarli?
Anche Fefè, che negli ultimi giorni trascorreva molto del suo tempo alla Torre per dare una mano, se ne era uscito a un tratto con una delle sue fantasie:
«Lo sapete – aveva confidato agli altri presenti, – cosa mi ricorda Theodoro e tutta questa misteriosa vicenda? Quel vecchio film dal titolo “La mummia vivente”, che raccontava la storia della mummia di un faraone trafugata da un archeologo inglese e portata clandestinamente in Inghilterra. Ebbene, da quel momento né lui né la sua famiglia avevano piú trovato pace. Che dico, tutta la regione intorno alla sua villa di campagna era caduta preda di una maledizione: morti a decine, malattie orribili e ignote, gente che impazziva senza un motivo apparente. Finché qualcuno non collegò i disastri con la presenza del sarcofago rubato. Lo riportarono al suo posto in Egitto e tutte le sventure finirono di colpo…».
Chiara reagí:
«Che vorresti dire, che adesso dobbiamo morire tutti perché Andrea ha scoperto la tomba di Theodoro?».
Fefè protestò:
«Non intendevo questo. Penso solo che le spoglie del Duca dovrebbero avere la loro giusta collocazione».
Come capitava spesso, le esternazioni di Fefè, cinico e pessimista di natura, contenevano un’essenza di verità, da interpretare però al contrario: da quando la grotta aveva rivelato le spoglie di Theodoro, qualcosa di speciale era accaduto, ma non si trattava di una maledizione. Andrea avvertiva che le ossa del Duca ucciso spargevano intorno non i letali umori della mummia egizia, bensí una ventata di aria nuova che scoteva tutto e tutti dall’interno.
Tra gli altri arrivarono anche i membri della giunta comunale, con il sindaco Bracconeri in testa. Scesero nella cripta, osservarono molto freddamente la nicchia e risalirono dopo pochi minuti, chiedendo di parlare con Andrea.
«Egregio signor De Marinis – esordí Bracconeri col tono delle occasioni ufficiali, – insieme ai colleghi della giunta di tutte le forze politiche, mi auguro che quello che abbiamo visto sia vero, per il bene di tutti. Se al contrario, e a questo fine indagheremo approfonditamente, si tratta di una manovra della reazione per disturbare le imminenti consultazioni elettorali, ebbene, noi agiremo con le armi che la legge ci accorda. Lei e i suoi amici, chiunque essi siano, siete avvisati!».
E dopo questa specie di solenne ammonimento, l’intera quadriglia dei politici, con muto sussiego, se ne andò. Fu quella però l’unica nota stonata in un contesto di generale approvazione ed entusiasmo.
Giungevano telefonate da ogni parte d’Italia e dall’estero. Chiamarono anche i figli di Andrea, Jane ed Andy:
«Tieni duro, daddy – lo incitarono. – Noi siamo solidali con te e con Theodoro. Stiamo interessando la stampa di qui per creare gruppi di pressione».
Quel week-end vennero a Pasidonia anche i figli di Marcella, Giorgio dall’Accademia di Livorno e Serena da Roma. Per una simile occasione, Mezzatesta volle organizzare una serata speciale al Miramare, alla quale furono invitati anche Chiara e Fefè.
Dopo cena si passò a parlare di strategia:
«Occorre formare con urgenza il Comitato Pro Theodoro – disse il barone. – Lo avete sentito il sindaco Bracconeri. Quella è gente che va per le spicce. Bisogna batterla sul tempo. Il Comitato dovrà essere formato da persone normali, non coinvolte nella lotta politica e nella gestione del potere, non invischiate in scandali, corruzioni e concussioni. Insomma, gente pulita e onesta. Ripeto, onesta…».
Fefè, che stava sorbendo un long drink, s’intromise con garbo:
«Con tutto il rispetto, caro barone, dove li trovate tipi simili? Neanche in un convento di clausura, scusate. Si tratta di una razza del tutto estinta nel nostro Paese, esclusi i presenti, beninteso…».
Come al solito, fu Marcella a portare la soluzione giusta al momento giusto.
«Ma tu – disse rivolta ad Andrea, – una volta, tanti anni fa, non avevi un gruppetto di amici per la pelle, una specie di brigata pronta a tutto?».
Sotto il suo abituale tono suadente, Marcella celava questa volta una sottile vena di ironia provocatoria. Andrea le rivolse uno sguardo interrogativo. Lei proseguí:
«Ma sí, te ne devi ricordare – insisteva, – eravate tanto affiatati e desiderosi di avventura che una volta avevate in mente addirittura di raggiungere in barca un’isola sperduta in pieno Oceano Indiano».
Fefè, divertito, intervenne:
«Che mi tocca ascoltare sul conto di mio cognato! Anche la tendenza alla navigazione transoceanica. Sentiamo, sentiamo!».
Il resto della tavolata interruppe le conversazioni per concentrare l’attenzione sui trascorsi nautici di Andrea. Questi, a tanto interesse, si schermí con un certo imbarazzo:
«Beh, si trattava di una ragazzata. Avevo forse quattordici o quindici anni. Era il periodo delle vacanze estive. Ricordo con esattezza il nome dell’isola: Albarès. Faceva parte di uno di quegli arcipelaghi tropicali composti di centinaia di isolotti al largo del Madagascar. Una delle poche che avesse abbondanza di vegetazione e riserve di acqua naturali. Pensate, l’avevamo individuata consultando i portolani e le carte nautiche del padre di uno dei ragazzi della comitiva, che aveva navigato per anni sui mercantili diretti in Oriente. Ci affidavamo alle cognizioni acerbe di marineria che aveva uno dei partecipanti, da poco iscritto all’Istituto nautico. Certo, c’era tanta improvvisazione e incoscienza, però la voglia d’avventura superava tutto».
Da uomo concreto, il barone intervenne per rivolgere una domanda pratica:
«Ma la barca? Per una traversata del genere vi ci voleva un battello di una certa stazza. Come ve lo siete procurato?».
«Era tutto predisposto. Ci eravamo accordati per prendere a nolo una delle grandi paranze che si affittavano ai forestieri per l’estate. E con la scusa di fare una battuta di pesca, avevamo caricato a bordo tutta la strumentazione e le vettovaglie».
«Chi l’avrebbe mai detto! Un cognato bucaniere e corsaro dei mari – insinuò con malizia Fefè. – Eh, sí! Perché da quanto ho capito, la barca non l’avreste mai piú riportata al proprietario!».
«E chi lo dice? Dopo qualche tempo, questo era nei progetti, saremmo tornati ricchi sfondati. Perché su quell’isola avremmo sicuramente trovato ambra grigia, spezie e pietre preziose. Bastava scavare e raccogliere. E una volta di ritorno ne avremmo comprate cento di paranze».
«Già, perché voi contavate non solo di arrivarci, ma anche di ritornare carichi di tesori!» commentò Chiara sarcastica.
Di nuovo il barone intervenne in tono risolutivo:
«E poi, come andò a finire?».
A quel punto tutta la tavolata era tesa alla conclusione della vicenda.
«Andò a finire – riferí in tono sbrigativo Andrea, – nel solo modo possibile. Le famiglie entrarono in allarme quando non ci videro rientrare a casa la notte. E in agitazione profonda piombò soprattutto Biagino, il proprietario della paranza, non vedendo riportare l’imbarcazione, come convenuto con i sedicenti pescatori di totani. Vennero avvisati i carabinieri e questi girarono la denuncia alla Capitaneria di porto. Ci bloccarono verso il mezzogiorno dell’indomani, quando stavamo per doppiare la punta Nicosa e uscire dal golfo. Naturalmente, poco credettero alla versione della deriva causata dal vento. Il vario e cospicuo materiale che avevamo a bordo non giustificava affatto una battuta notturna di pesca. Ma neppure lasciò intuire alle guardie il vero scopo della spedizione. La notorietà comunque non mancò. Sulla spiaggia attendeva una folla di parenti e amici, oltre, s’intende, a Biagino, combattuto tra la collera e l’orgoglio di quell’inatteso ruolo di protagonista. Per questo, forse, si limitò a intascare un congruo noleggio, senza sporgere denuncia».
«Devi ringraziare gli addetti alla Capitaneria, caro cognato – sentenziò gravemente Fefè, – perché, senza il loro intervento, chissà dove sareste approdati… o affondati!».
«Chi lo può dire – s’intromise benevolo l’avvocato Carossa a difesa di Andrea, e forse con qualche rimpianto per la sua gioventú. – A quell’età si è capaci di tutto. Magari a quell’isola ci sarebbero arrivati sul serio!».
«Sí, in bocca a qualche squalo!» insistette macabro Fefè.
«Comunque – riprese a dire Mezzatesta, – sarebbe in grado di contattarli, Andrea, quei suoi amici di allora? Se a quel tempo erano disposti a rischiare tutto con lei, forse oggi potrebbero darle una mano per il Comitato Pro Theodoro. Che ne dice?».
«Per quanto strano possa apparire – si giustificò l’interpellato con imbarazzo – da quando sono tornato dall’America non li ho ricercati».
S’intromise la voce di Marcella:
«Ecco qui la lista completa, con nomi e indirizzi».
Andrea era turbato, ma provava anche una leggera forma di compiacimento vedendo che Marcella conosceva molti dettagli della sua vita passata.
Il barone si avvicinò ad Andrea e, mentre gli poggiava una mano sulla spalla, con il suo sguardo magnetico lo fissò, chiedendogli deciso:
«Allora, amico mio, se la sente di cominciare subito domattina a ricomporre la ciurma? Abbiamo poco tempo, lei lo sa meglio di me. Bracconeri non ci darà tregua, e poi lui ha una barca con piú vogatori della nostra. Dobbiamo fare in fretta, muoverci prima».
L’altro annuí con un cenno del capo.
Piú tardi, quando Andrea si trovò per un attimo solo in disparte con Marcella, le chiese:
«Adesso devi spiegarmi come…», ma lei lo interruppe facendo apparire dalla sua borsetta un quadrato di carta azzurrina. Sotto gli occhi di lui lo svolse, e il quadrato si trasformò nel rettangolo di una lettera.
«Te la ricorderai, spero» disse Marcella fissandolo con aria di sfida, e gli porse il foglietto.
«Ma questa è la mia calligrafia, è una lettera mia!».
«Una delle tante che allora mi mandavi. Come ti ho già detto, le ho conservate tutte. Questa però occupava un posto d’onore, era importante. Mi confessavi che stavi partendo per sempre e che mi amavi come non avresti mai piú amato un’altra donna nella tua vita. È stato veramente cosí?».
Andrea non rispose. Era intento a leggere quelle ingenue righe tracciate tanti anni prima. C’erano tutti i nomi dei suoi amici imbarcati in quella folle avventura, anche i nomignoli e le loro manie personali.
«Non mi hai ancora risposto…» insistette lei. E Andrea, con calma:
«L’amore è quello che si vive giorno per giorno. Allora io e te non ci frequentavamo neppure. Credo di averti toccato una sola volta fisicamente, per caso, all’entrata della scuola, perché pioveva e c’era ressa. Tu, come al solito, non te ne accorgesti neppure. Ma io restai come stordito per tutta la giornata a pensarci su. Stordito ma felice, perché ti avevo sfiorata, avvertendo di sfuggita il tuo profumo».
Dopo un breve silenzio, Andrea riprese:
«Vedi, tu hai amato tuo marito e io mia moglie, perché hanno diviso con noi le gioie e i dolori della vita, ci hanno dato una mano per rendere piú facile il cammino».
Di nuovo tacque, poi, prendendole la mano, esclamò con tono piú sicuro:
«Ma quello che conta adesso è il presente, è che ti ho ritrovata e che ci amiamo».
«Sí, hai ragione – concordò Marcella, volgendo verso di lui il volto sereno e determinato. – Pensiamo al presente e all’impresa che ci attende. Domani dobbiamo occuparci del Comitato, è la cosa piú importante».
«No, del Comitato mi occuperò io. Tu invece starai coi tuoi ragazzi. Li accompagnerai alla Torre a vedere la casa, le mie anticaglie e soprattutto Theodoro. Poi pranzeremo tutti insieme. I miei amici, preferisco contattarli da solo. Credo sia meglio. Ti confesso che non so neppure come reagiranno alla proposta. Ormai saranno degli argonauti alquanto stagionati: già allora non scherzavano in fatto di carattere riottoso!».
«Adesso come allora – commentò Marcella, – devi accordare loro la necessaria comprensione per chi s’imbarca sulle rotte dell’ignoto».
SI RICOMPATTA LA CIURMA
Dopo aver navigato con alterna fortuna i mari burrascosi della vita, i prodi nocchieri della mancata conquista di Albarès si erano tutti arenati nel ristretto spazio che comprendeva il lungomare, la piazza grande e un paio di vicoli laterali che dal centro conducevano al porto.
Chi aveva osato di piú nei suoi peripli esistenziali era stato Peppino Savasta, detto “ ’o Francese”. Invaghitosi di una parigina venuta a Pasidonia con uno dei tanti gruppi culturali estivi, l’aveva seguita in Francia e qui se l’era sposata, scoprendo subito però che la fragile, sofisticata, all’apparenza angelica creatura, nascondeva dentro una donna dall’ambigua personalità, che conduceva una doppia vita. Nel volgere di pochi mesi, da una tranquilla esistenza di vitellone di provincia Peppino si era visto proiettare in un vortice di mondanità sfrenata, frequentando l’entourage della bella Jasmine, cosí si chiamava la moglie. Traffici poco chiari, amicizie equivoche. Finché una sera Peppino non venne preso, nel corso di una retata della polizia francese, in un lussuoso château alla periferia della capitale, che risultò essere, invece, un centro per lo spaccio della droga e forse punto di smistamento della tratta delle bianche. Benché apparisse abbastanza lampante agli inquirenti francesi che Peppino era il classico pollo coinvolto in un gioco piú grande di lui, pure gli fecero passare ben sei mesi nelle prigioni parigine. Scontata la pena, con la moglie ancora dietro le sbarre, senza un lavoro, si mise a fare di tutto: dal muratore al barbiere, dal cameriere al buttafuori in un bistrò della Rive Gauche. Il locale si chiamava “Jolie môme”, termine che in argot, il dialetto parigino, sta a definire una bella ragazza. Questo nome, un modesto gruzzolo di franchi e un gran barbone da “peintre maudit”, fu tutto quanto Peppino riportò dalla sua avventura francese. Tanto per darsi un pretesto di vita attiva, mise su una boutique di articoli per la spiaggia: costumi, borse, occhiali, sandali, e sul frontespizio del piccolo locale appese una targa di legno dipinta a mano col titolo “Jolie môme” con accanto la sagoma stilizzata della Tour Eiffel, a memoria dei suoi movimentati trascorsi parigini.
Ora però, dopo aver lottato con le donne, la polizia e le insidie della Ville Lumière, si era imbarcato in un conflitto ben piú letale: quello col fisco italiano. Quando Andrea varcò la soglia del negozio, Peppino stava appunto inveendo al telefono contro “la sanguisuga dello Stato”.
Si interruppe, per gratificare l’amico con un fugace gesto della mano libera dalla cornetta, e per consentire al suo interlocutore all’altro capo del filo di dire la sua. Andrea riusciva a udire la voce da ectoplasma sortire gracchiando dal ricevitore e diffondersi per il locale con un vago ronzio da insetto molesto.
«Vuol dire che pagherò anche stavolta – concluse Peppino a un certo punto, annuendo piú volte rassegnato e cercando con lo sguardo acceso dal disappunto la solidarietà di chi gli stava di fronte. Poi ci furono i saluti a denti stretti e la mano che, deposta la cornetta, si tese a stringere quella del nuovo arrivato.
«Scusami, era il commercialista – chiarí ’o Francese. – Sei capitato in un brutto momento. Soldi. Tutti vogliono soldi, tanti, sempre. Mi telefona persino di sera tardi a casa, il dottor Maresca, per ricordarmi, non che devo morire come i monaci trappisti, ma peggio che devo pagare, regolare, anticipare, versare…».
Ormai Peppino andava a ruota libera nel suo sfogo di tartassato, e Andrea lo lasciò fare. L’invettiva dell’amico era a quel punto il grido di dolore di tutto un popolo, quello italiano, costretto a tollerare da parte del fisco prelievi che toccavano, a detta dei media, picchi esattivi del 50 per cento e oltre.
«Ma non basta il salasso –proseguí infervorato e senza freni né remore Peppino. – Ti costringono alla tortura di file interminabili alle poste e alle banche per effettuare i versamenti entro le scadenze. E guai a sgarrare. Guarda! – Aprí un registro dalla copertina verde e lo rigirò dalla parte di Andrea. Numeri a molte cifre riempivano colonne e quadrettini, timbrature enormi suggellavano i totali e i riporti. Dopo quello, Peppino ne squadernò altri, di varie forme e funzioni. Anche qui cifre, vidimazioni e bolli.
«Tu capisci, Andrea, per mandare avanti un buco di quattro metri per sei come questo, e ricavarci un obolo per campare alla meno peggio, mi tocca tenere una contabilità da grande azienda. E se sbagli una virgola, se cancelli un numero errato, devi giustificarti quasi fossi un criminale. – Sconsolato indicò con un ampio gesto la merce tutt’intorno: – In fondo si tratta di innocui articoli da spiaggia… E già parlano di computer da installare, di programmi di accounting collegati alla rete, di esperti da pagare profumatamente…».
La foga di Peppino si esaurì per mancanza di fiato e di carica emotiva. ’O Francese tacque, svuotato. Andrea gli prese di nuovo la mano, stringendola forte, cercando di passargli un po’ di conforto e simpatia con quel contatto.
«Oh, Andrea – riprese Peppino in tono dolente, – come era semplice la vita anni fa! La testa non si perdeva dietro a tutti questi conti. Mi dispiace, ti ho accolto nel modo peggiore!».
«Se può aiutarti – disse Andrea, – ti assicuro che è dappertutto uguale nel mondo, persino in America. I vari poteri che gestiscono i servizi diventano sempre piú esosi, spietati, e non solo nel campo commerciale, anche nella vita normale, domestica. Ti fanno pagare fino all’ultimo centesimo per il suolo che occupi, per l’acqua che bevi, l’elettricità che consumi, le strade che percorri».
«Ma allora – fece sconfortato Peppino, – non c’è soluzione al problema?».
«Sono venuto giusto a offrirtene una. Magari non risolverà tutti i guai, forse non ne risolverà neppure uno, o te ne creerà altri, ma io te la propongo lo stesso».
«Di che cosa si tratta?» chiese l’altro.
«Vorrei che tu aderissi al Comitato Pro Theodoro».
«Ah, parli del Duca che hai scoperto nella Torre sotto casa tua?».
«Già, proprio di quello. Ci stai? Non c’è guadagno materiale, ti avverto. Il premio è alla fine, se tutto andrà bene. Ti ricordi di Albarès?».
Peppino fissò lo sguardo nel vuoto per inseguire memorie di tanti anni prima. Poi, sorridendo come un bambino, esclamò:
«La nostra isola incantata…».
«Ecco – riprese Andrea – esattamente come quella. Ma adesso c’è da correre un po’ piú di rischi. Ci stai lo stesso?».
«Quanti siamo?» chiese distrattamente Peppino, perduto ancora dietro ai ricordi.
«Tu sei il primo».
L’altro si riscosse, come tornando da un lungo viaggio:
«Ci sto, certo che ci sto. E gli altri, chi erano gli altri? Aiutami a ricordare!».
Andrea nominò il resto dei partecipanti alla spedizione. Man mano che elencava i nomi e i nomignoli di battaglia, l’amico sorrideva. Finché Andrea non rievocò il rientro forzato sotto scorta. Peppino allora, divenuto serio, commentò:
«Ma forse fu un bene…».
«L’importante però fu di averci provato. A quell’età certe cose vanno fatte. È quasi un dovere» sentenziò Andrea.
L’altro aggiunse sottovoce:
«Io credo che si debbano fare a tutte le età, Andrea, anche a novant’anni. Per sentirsi vivi. Per questo ci sto, senza neppure sapere nulla del tuo Duca e dei rischi di cui parli. Mi sento già a bordo della barca, con trent’anni di meno. I suoi occhi adesso brillavano.
«È l’unico modo – proseguí per averla vinta sui mostri dei numeri e delle esazioni, che vorrebbero toglierci la voglia di vivere», e cosí dicendo richiuse uno dopo l’altro i registri e i bollettini, facendoli sparire nell’ampio cassetto del bancone.
«Bravo, Peppino! – si complimentò Andrea sorridendo. – Facciamo trionfare la poesia e la favola sull’aridità dei numeri. Theodoro, il duca verace, ci aiuterà in questo».
L’amico, affascinato dalla seduzione operata da quelle parole, sussurrò attraverso il suo barbone da artista maledetto:
«Parlami di Theodoro e del Comitato».
Titino Bonadei, detto ’a Trippa per la grossa pancia che aveva sviluppato negli ultimi anni, non si era mai mosso da Pasidonia, al contrario di Peppino Savasta. Dopo essersi diplomato in ragioneria, aveva rilevato una cartoleria in cui vendeva di tutto, anche chincaglieria e profumeria. Una specie di bazar da posto di tappa lungo le carovaniere.
«Andrea carissimo – esordí Titino, appena vide il suo vecchio amico – ho sentito che ora ti dedichi alla scoperta di duchi destituiti. Mi accorgo che questa attività è salutare, perché ti trovo molto bene: snello, dinamico, scattante. Mentre io, con questa pancia!…».
«Se ben ricordo, avevi un debole per la pasta e fagioli… Mi accorgo che quella passione ti è rimasta!».
Titino rise divertito e la sua pancia sussultò piú volte.
«Magari dipendesse solo dai minestroni… – si giustificò. – Il mio vero problema sono i clienti, soprattutto i bambini. Quando tutti eravamo poveri, bastava un pupazzetto di stoffa cucito alla meglio dalle donne di casa, i pulcinella che battevano le mani, le trottole di legno che ci facevamo da noi, gli zufoli di canna. Te li ricordi? Bastava un niente per farci correre allegri da un posto all’altro e la sera cadere addormentati e sognare gli angeli che cantavano o che giocavano con noi a sottomuro con i bottoni vecchi… Oggi i bambini vogliono solo oggetti sofisticati, persino mostruosi. Lo sai cosa va molto adesso? Non lo crederesti mai: il bone cruncher, che non è altro che un mostro divoratore di altri mostri. Se li mangia sgranocchiandoli come mio zio Raffaele faceva con le alici fritte: se le infilava in bocca intere e, dopo averle masticate, ne ingoiava soltanto la polpa, sputandone la lisca e le spine. Era un fenomeno, zio Raffaele. Noi piccoli aspettavamo che si accingesse a mangiare le alici, e andavamo a chiamare gli amichetti del vicinato perché ammirassero quello spettacolo. Adesso invece, guarda – e prese dallo scaffale alle sue spalle un giocattolo dai colori sfacciati, – questo mostro dai denti d’acciaio stritola con una leggera pressione della sua mascella un suo pari meno dotato di lui. Ecco, questo vogliono, e se ti azzardi a proporre un Pinocchio di legno è il finimondo. Quanto alle donne, poi! Sono appena uscite due signore, madre e figlia. Mi hanno fatto letteralmente impazzire. Hanno provato tutte le collane: questa non andava perché era “datata”, l’altra era “out” per il look, la terza non era firmata… Sono andate via disgustate, come se avessi proposto loro le perline di vetro che Cristoforo Colombo offrí ai selvaggi delle Indie Occidentali».
Titino sarebbe andato avanti per un pezzo con il suo monologo, se Andrea non lo avesse interrotto solidarizzando con le frustrazioni e le nevrosi dell’amico. Arrivò quindi all’argomento che gli stava a cuore:
«Sono venuto a proporti di far parte del Comitato Pro Theodoro per la riabilitazione del Duca, facendo luce sulla sua barbara fine, nell’interesse della città. Volevo sapere se posso contare su di te. Sto contattando tutti gli altri della spedizione marinara…”
«Di nuovo in rotta per Albarès? – chiese Titino con un guizzo di eccitazione negli occhi – Di nuovo sulle onde?».
«Non so quale impresa sia piú ardua, se vendere una collana non firmata a una signora bisbetica o riabilitare un duca detronizzato. Sei libero di accettare o di rifiutare, si capisce. Come allora. Libero di salpare o restare sul bagnasciuga».
Ostentando una inattesa euforia, Titino accarezzò piú volte l’ampia rotondità del ventre a stento trattenuta dalla camicia:
«Eh no, caro mio! Prima mi metti nell’orecchio il rumore della risacca e il frusciare delle palme sulla spiaggia di Albarès e poi mi dici che sono libero di restare a terra. Ma di quale libertà parli, di questa?» e indicò, con un ampio gesto sconsolato, gli scaffali ingombri di un eterogeneo, variopinto bric-à-brac.
Terminata la stagione estiva, Enzo Doria, detto “’o Principe”, non si alzava mai prima delle dieci del mattino. Questa sua inclinazione al buon dormire non gli veniva dalla pigrizia, quanto piuttosto dal fatto che la sua famiglia gestiva, da generazioni, i bagni a mare. Gli stabilimenti, montati su palafitte di legno, offrivano ai villeggianti il comfort di cabine e spogliatoi dipinti in allegri colori, e sull’arenile ombrelloni e sedie a sdraio, dagli inizi di marzo a tutto settembre. Era un’attività questa che, per il periodo della sua durata, non concedeva tregua, permettendo scarso e fugace riposo. Questo si riduceva, per lo piú, a pennichelle rubate allo scarso tempo libero lasciato dall’incessante lavoro sulla spiaggia, al bar e intorno alle cabine.
Iniziata in forma blanda con l’avo di Enzuccio, la necessità di sonno si era andata radicando sotto forma di sgradita sindrome nel padre, divenendo con lui una vera e propria malattia. Unico rimedio, inutile dirlo, dormire. Per cui, terminata la stagione, Enzuccio sull’esempio degli orsi canadesi cadeva semplicemente in letargo e, fatta eccezione per i pasti, le impellenze fisiologiche e qualche faccenda domestica di particolare gravità, non si staccava dal suo letto fino all’arrivo della primavera successiva. Il titolo di Principe glielo avevano affibbiato gli amici, in quanto era prerogativa dei nobili, nel buon tempo antico, di alzarsi a giorno inoltrato.
Quando Andrea si recò a trovarlo, la moglie di Enzo, Rosa, gli disse con aria apprensiva:
«Speriamo che non si spaventi!».
«E perché dovrebbe spaventarsi?» osservò stupito Andrea.
La donna, mentre lo precedeva verso la camera da letto, gli spiegava il problema parlando sottovoce, come una conversa in un monastero di clausura:
«Enzuccio è rimasto impressionato dall’ultimo terremoto. Dormiva talmente sodo che non l’ha sentito, e nessuno è riuscito a farlo scendere dal letto. Anche perché, capirai, con tutto il fuggi-fuggi, pure noi a un certo punto siamo corsi per strada, scappando, non mi vergogno a dirlo, come lepri. Quando Enzuccio ha saputo del pericolo che aveva corso, ha avuto un “trauma di ritorno”, cosí l’ha chiamato il neurologo. Pare che sia una paura piú forte di quella immediata, presa lí per lí mentre una certa cosa ti sta succedendo. E adesso…».
Poiché erano arrivati presso la camera, la donna s’interruppe per un attimo, poi aggiunse:
«Beh, adesso lo vedrai da te».
Andrea vide che si trovavano in fondo al corridoio dove c’erano, se ben ricordava, la dispensa e il ripostiglio che davano sul retro, dalla parte del giardino.
«Ma qui non ci dovrebbero essere le camere da letto» osservò.
«Hai ragione – rispose la donna, – vedo che hai buona memoria. Infatti le camere da letto vere e proprie sono rimaste a metà del corridoio e danno sulla strada maestra, a un’altezza di otto metri e passa. Troppo alto per buttarsi di sotto».
Andrea non capiva.
«Come sarebbe, buttarsi di sotto? Chi dovrebbe farlo, e perché?».
«Nessuno, nessuno – tentò di chiarire, bisbigliando concitata la donna – almeno in tempi normali. Ma quando c’è un terremoto come quello dell’ultima volta, non so se mi spiego…».
Cadde un imbarazzato silenzio tra i due, poi Rosa proseguí in un sussurro:
«Insomma, caro Andrea, Enzuccio è rimasto talmente impressionato che ha voluto spostare la nostra camera da letto qui, dove una volta c’era la dispensa. In maniera che, se succede, lui si può catapultare dal letto diritto fuori nel giardino. Sono appena tre metri e si finisce nella terra o su una pianta di limone. Lui dice che con un po’ di fortuna, cadendo bene, uno se la cava. Al massimo può rimediare una sbucciatura al ginocchio, una slogatura o un bernoccolo in testa. Per ogni evenienza, comunque, tiene anche una corda a portata di mano…».
Andrea, strabiliato, avrebbe voluto chiedere a Rosa maggiori dettagli sulla faccenda, in particolare se anche lei, in caso di terremoto, sarebbe saltata dalla finestra seguendo, come vuole la regola coniugale della buona e della cattiva sorte, il marito nevrotico. Ma non fece in tempo a parlare perché intanto lei, con circospezione, premendosi l’indice sulla bocca a intimare cautela e silenzio, spinse la porta della camera da letto ex dispensa. Andrea si aspettava un locale al buio completo, invece notò che una lampada fioca, di quelle che si tengono accese nelle camere dei malati gravi negli ospedali, irradiava intorno un lucore giallognolo. Cosí poté vedere ben distintamente Enzuccio steso sul letto, e la corda: un lungo canapo da ormeggio, un capo annodato a una chiavarda di ferro murata sotto la finestra, e l’altro arrotolato presso il letto, pronto per essere lanciato fuori in caso di fuga.
«Enzú – chiamò a mezza voce Rosa, nella penombra sinistra – ci sta il tuo amico Andrea, svegliati!».
Un grugnito fu la risposta. Di nuovo la donna ripeté:
«Su, alzati, ci sta Andrea. Ti deve parlare» e per raggiungere piú rapidamente lo scopo, afferrò un piede del marito che fuoriusciva dalle lenzuola, tirandolo. Enzo si sollevò di scatto e, rimanendo seduto in mezzo al letto, rivolse subito gli occhi sbarrati al lampadario. Non vedendolo oscillare o sobbalzare, si tranquillizzò.
«Scusami, Enzo – disse subito Andrea, – non avrei voluto disturbarti, ma si tratta di una cosa della massima importanza e urgenza. Riguarda Theodoro. Avrai letto sui giornali, avrai sentito alla radio e anche alla TV…».
Rosa scosse la testa:
«Lui in questi giorni, da adesso fino a marzo prossimo, è come se vivesse su un altro pianeta. Inutile fargli domande del genere».
Enzuccio ritrovò un po’ del suo passato smalto. Si rivolse all’amico, sempre restando nella stessa posizione, ancora in semiletargo:
«Certo che non sei cambiato affatto. Venivi a svegliarmi alle sei del mattino, allora, per andare a fare le tue gite, e non hai perduto il vizio. Che niente niente vuoi ricominciare adesso con le avventure verso i paesi ignoti e lontani?».
«Vedo che la memoria non ti si è affievolita a furia di dormire. Ti ricordi ancora di Albarès?».
L’altro si ravvivò:
«Se me ne ricordo! Per fortuna arrivò la Capitaneria, altrimenti chissà come saremmo finiti!».
Tacque per qualche attimo poi, puntando un dito contro Andrea, aggiunse:
«Non mi dire niente. Lo so perché sei venuto qui a svegliarmi: vuoi che mi unisca a te per fare quel tuo Comitato, quello del referendum a favore di Theodoro…».
«Per essere uno che dorme e che non raccoglie informazioni, ne sai già molto…» rise divertito Andrea.
Enzo abbozzò un’espressione maliziosa:
«Sí, dormo, ma le notizie che contano, quelle non mi sfuggono, e per un avvenimento eccezionale come il ritrovamento di Theodoro, non c’è sonno che tenga!».
«Non vorrai continuare a parlare stando a letto!» s’intromise Rosa con aria di rimprovero.
Riluttante, Enzo si alzò, bevve un caffè e, dopo una chiacchierata di un quarto d’ora, anche lui era reclutato.
Prima di lasciarlo, Andrea non poté trattenersi dal ritornare sul particolare che piú lo aveva colpito:
«Dimmi un po’, Enzo, questa faccenda del terremoto, conti di risolverla in qualche modo?».
L’altro rispose con serietà:
«Vedi, Andrea, questo è un argomento tabú, non perché mi secchi parlarne, e poi tu sei un amico. No, il fatto è che non so come spiegarlo, è piú forte di me. Mi capita però solo quando sto a letto, quando sto in piedi, invece, sono perfettamente normale. Il medico dice che per togliermi lo choc ci vorrebbe un’altra esperienza simile, per ottenere la “rimozione d’angoscia”… Ti ripeto quello che dice lui».
«Se ho ben capito, dovresti prenderti un’altra paura uguale a quella passata, per guarire».
«Ecco – ammise Enzo – piú o meno questo. Ripetere l’esperienza che ha originato il trauma. In poche parole, Andrea mio, ci vorrebbe un altro terremoto…».
Intervenne sarcastica la moglie:
«Eh già, noi adesso facciamo voti alla Madonna di Pompei perché ci mandi un bel sisma del nono, decimo grado della scala Mercalli, con movimenti sussultori, ondulatori e vibratori, cosí il povero Enzo Doria, mentre il mondo crolla e la gente muore a migliaia, riesce a rimuovere la causa del trauma!».
«Quanto sei esagerata! Il neurologo parla solo in termini tecnici. Non si occupa di miracoli».
«Per fortuna nostra!» aggiunse ostinata Rosa, che volle avere, com’era suo solito, l’ultima parola.
Dopo Enzo Doria, fu la volta di Vittorio Caporaso, detto “’o Lampione” a causa della sua lucida pelata rossiccia. Ora gestiva l’agenzia di viaggi “Globetrotter International” nel vicolo di Porta Marina, ma si occupava anche di camere in affitto, cambio di moneta e, per arrotondare, teneva i conti di alcuni alberghi. Aveva tre figli, un paio di spessi occhiali da miope e sotto questi esibiva, quando rideva, una chiostra di denti gialli per il fumo che vi transitava in permanenza. Andrea ebbe il sospetto che gestisse anche una bisca clandestina, ma era solo un’impressione. Tutto dipendeva forse dalla particolare atmosfera che si respirava nei locali dell’agenzia. Dal mare irrompevano odori gravati di salsedine, che percorrevano corridoi e stanze, sprigionando dai vecchi mobili sottili vapori di muffa. Vuoi per questi umori vuoi per la figura del proprietario, la Globetrotter International ricordava una taverna d’angiporto, uno di quei posti ai margini della civiltà dove, nei tempi d’oro della navigazione a vela, si coordinavano operazioni di contrabbando di rhum e tabacco, oltre al reclutamento forzato di marinai per le navi che partivano senza alcuna speranza di ritorno.
Vittorio accettò la proposta di Andrea, sfoggiando un sorriso da Budda cinese di vecchio avorio.
Venne poi il turno di Gerardo Scuotto, detto “’o Suffritto”. Gerardo aveva studiato da geometra, ma ora gestiva un motel con annesso night club e discoteca. Era la vecchia bettola di suo nonno che un tempo dava da mangiare ai carrettieri di passaggio e che lui aveva trasformata, rietichettandola. Un tempo la chiamavano semplicemente “da ’o Capitano”, perché il nonno comandava una tartana di dodici metri che si spingeva fin oltre la Punta Nicosa per la pesca d’altura. Adesso Gerardo dirigeva il suo “Acapulco Buffet Night Disco and Fast Food” con piglio nuovo, che faceva tanto Las Vegas.
Il motel affacciava direttamente sulla strada rotabile che seguiva la Costa fino a Portoreale. Subito dopo l’abitato, il serpentone di curve e cunette si distendeva in un breve rettilineo. Qui, a sinistra della carreggiata, era stata installata una pompa di benzina. Sulla destra, lato mare, uno slargo adibito a parcheggio fungeva da invito all’edificio che ospitava il motel e la discoteca. Un tempo al posto dell’asfalto c’erano ghiaia e terra battuta. Non di rado, nei giorni di burrasca, mancando ancora il frangiflutti di cemento costruito in seguito, il mare scavalcava l’incerto baluardo di scogli bassi e sabbia e invadeva il cortile della taverna gestita dal nonno di Gerardo. Ma nessuno ci faceva caso, né il nonno né sua moglie, una donna forte e autoritaria. Tantomeno se ne preoccupavano i carrettieri che facevano sosta per rifocillarsi e far bere i cavalli. Coprivano il carico con ruvide cerate e gli animali con stracci di fortuna per ripararli dal salino che si scioglieva nell’aria, nebulizzandosi.
Andrea, arrivando nello slargo, notò alcune ragazze che sostavano nel piazzale, quasi a ridosso della sede stradale. Si rese conto che facevano parte di una lunga fila che partendo dalla strada finiva all’ingresso della discoteca. Al centro dell’edificio invece una vistosa porta a vetri anodizzata immetteva direttamente nel motel. Andrea vi entrò attraversando poi il vestibolo maiolicato.
«Buongiorno, desidera?» chiese un giovane in abito scuro, ritto dietro il bancone del ricevimento.
«Buongiorno! – ricambiò il nuovo arrivato. E poi: – Sto cercando il proprietario».
«Padre o figlio?» domandò l’altro.
Dopo un attimo di esitazione, Andrea rispose citando nome e cognome del suo amico.
«Allora il padre – confermò il giovane, con una vena di sufficienza nella voce – Venga con me, l’accompagno io».
Mentre si incamminavano, squadrò incuriosito Andrea.
«Per caso – s’informò, –si occuperà della scenografia?… Viene da Napoli?».
«No – fu la secca risposta. – Io abito qui, a Pasidonia».
«Strano – fece l’altro, – non mi sembra di averla mai incontrata… Ecco, quello è l’ufficio del signor Scuotto» e indicò una porta in fondo al corridoio.
Mentre vi si dirigeva, Andrea poteva udire, provenienti dalla discoteca, le dissonanze di una musica rock: da queste emergevano i colpi secchi delle percussioni sonate con violenza e i suoni lamentosi delle tastiere. Su tutto, alternandosi al frastuono degli strumenti, una voce stentorea scandiva ordini a invisibili ballerini, o meglio ballerine, dedusse Andrea, ricordando le ragazze che si pigiavano in fila all’ingresso della discoteca sul piazzale.
«Andrea carissimo, da quanto tempo, e che onore!».
L’amico si alzò di scatto dalla poltroncina che occupava dietro la scrivania lucidissima. Gli venne incontro sfoggiando un largo sorriso, poi lo abbracciò, e prima che Andrea avesse il tempo di organizzare una strategia di convenevoli soggiunse:
«L’americano! Cosí ti chiamano adesso, è vero?».
Lo fece accomodare.
«Vuoi bere un drink?» incalzò, e prima che il nuovo arrivato potesse acconsentire o rifiutare, Gerardo pigiò rapido un pulsante sul ripiano della scrivania.
Apparve un cameriere in camicia bianca e pantaloni neri trattenuti in vita da un’ampia fascia elastica.
«Gennaro, per favore, portaci due bitter. – Poi, rivolto ad Andrea: – Ti va bene o vuoi un’altra cosa? Magari un whisky… Voi americani, lo so, lo bevete a tutte le ore».
«Non io! – chiarí subito Andrea. – Un bitter va bene». Poi, dopo un attimo, chiese: «Chi sono tutte quelle ragazze all’ingresso del locale?».
L’amico si agitò sulla poltrona e spalancò gli occhi scurissimi, mentre poggiava le mani sulla scrivania, abbrancandola con vigore.
«Hai visto che classe? Sai, è un’idea di mio figlio Sandro… Dice che l’anno prossimo vuole rinnovare il locale. Non piú liscio, easy listening e soft, roba antica, dice lui, passata di moda. Il “Sibilla”, la discoteca nostra concorrente, quest’estate si è lanciata con la musica techno e la black. Ma noi faremo di piú – si arrestò, quasi volesse preparare Andrea alla strabiliante notizia, – noi l’estate prossima faremo furore con le cubiste geishe: dieci splendide ragazze dai quindici ai vent’anni, non oltre, bada. Balleranno sui cubi multicolori e nelle gabbie dorate, sotto sciabolate di raggi laser, al ritmo della nuova danza, il Barochan. Sai cosa significa?» e qui lo sguardo dell’amico tentò di farsi malizioso. Fece seguire un “Eh eh” allusivo mentre con la mano sottintendeva chissà quali implicazioni trasgressive. Poi tacque trattenendo la rivelazione sospesa a mezz’aria, in attesa che lo stupore e la curiosità lievitassero nella mente del visitatore. Non rilevando alcuna reazione degna di nota, precisò:
«Significa “Lasciamoci andare”. Ti garantisco che sbancheremo il mercato notturno della Costa».
In quel momento arrivarono i bitter.
«Ma cosa c’entrano le geishe?» provò a chiedere Andrea, ora che la foga dell’amico si era in parte calmata.
«Ah, le geishe! Ma sono, come tu sai, le entreneuse giapponesi. Le nostre, tra un’esibizione e l’altra, gireranno tra i tavoli e con un sorrisetto, una strizzatina d’occhio, convinceranno i clienti a passare dai soft drink alla vodka, al bourbon, allo champagne. L’idea di mio figlio è che vadano impegnate al massimo, per tutta la serata, senza tempi morti. Solo cosí rendono e invogliano i clienti a tornare»
«Ma sono ragazze giovanissime, quasi bambine!» obiettò sconcertato Andrea.
In Gerardo un certo imbarazzo prese il posto dell’euforia.
«Sí, hai ragione – ammise, – quasi bambine. È quello che anch’io ho detto a mio figlio. Ma lui mi ha risposto, molto cinicamente per la verità, che il cubo e la gabbia sono meglio della futura disoccupazione e del marciapiede. Sono tutte ragazze che studiano, alcune anche diplomate, di buona famiglia, che cercano di assicurarsi un avvenire. Le entrate nelle famiglie sono quelle che sono… poi i mutui, le tasse… e allora le ragazze ci provano. Chissà, magari una sera, tra il pubblico che frequenta gli spettacoli, potrebbe capitare un talent-scout, un produttore cinematografico, magari un anchor-man televisivo, chi lo può dire?…».
«Ma adesso, che fanno tutte in fila là fuori?» chiese Andrea interrompendo l’amico.
«Un’audizione, – chiarí quasi con un sospiro l’altro. – Sandro e il coreografo fanno le selezioni per scegliere le migliori, le piú adatte. Perché vedi, non basta il fisico, secondo mio figlio, ci vuole qualcosa dentro… Mi capisci, no? Quel certo quid che smuove, seduce. E ci vuole un occhio esperto per coglierlo, specie nelle ragazze acerbe, alle prime armi…».
L’amico si fece pensoso, poi riprese:
«Vedi, mio figlio ha frequentato l’inverno scorso i locali alla moda piú prestigiosi di Roma, le discoteche dei vip, i loft piú in della capitale, dove s’incontrano stilisti, modelle, attrici e nobildonne. Lui sí che ci sa fare, io non riesco a stargli dietro! È un’altra generazione, hanno sogni diversi, piú concreti. Noi sognavamo isole perdute, questi invece se le creano qui, subito, senza rischiare, le isole».
Il tono dell’amico da entusiastico s’era fatto amaro, e mostrava il suo reale stato d’animo dietro il glamour sfoggiato fino a quel momento. Non fu perciò difficile ad Andrea coinvolgere anche lui nell’impresa.
Chiudeva la lista dei reclutati Guglielmo Pappalardo, detto “Abbondanza”, ultimo discendente di una sanguigna schiatta di salumieri. A suo tempo si era occupato dell’approvvigionamento alimentare della spedizione ad Albarès e aveva imbarcato una cesta intera di gallette e due grosse forme di pecorino stagionato, creando non pochi problemi di spazio a bordo. Iniziati gli studi per diventare avvocato, alla morte del padre, pur continuando a dare esami saltuari e sempre piú radi, si era dovuto occupare di prosciutti di Norcia, caciotte pugliesi e provoloni di Gragnano. Ma accanto a questa attività che non lo gratificava piú di tanto, nutriva il suo grande hobby, la sua vera passione: dirigeva il Club Azzurro “Ciuccio fa tu”, e quando la squadra del Napoli giocava, fosse inverno o estate, con pioggia o vento, in Italia o all’estero, Guglielmo avviava la schiera degli iscritti verso la tenzone contro le tifoserie avversarie.
Mostrò con orgoglio ad Andrea le panoplie appese al muro del negozio, a far capolino tra salumi e caciocavalli: gli stemmi, gli stendardi, le coppe e i gagliardetti. Alla proposta per il Comitato Pro Theodoro, garantí con solennità:
«Il nostro Club non si tirerà indietro neppure davanti a questa battaglia. Theodoro, il Duca verace, il martire e l’eroe, avrà tutto il nostro appoggio. Parola d’onore!».
Dopo la tornata delle consultazioni e dei reclutamenti, Andrea fece ritorno alla Torre. Era stanco ma soddisfatto, pieno di emozioni diverse e contrastanti. Gli amici che aveva rivisto erano uomini con i loro difetti, le umane paure, le grandi ambizioni e frustrazioni. Alcuni erano disillusi. Ma tutti avevano detto di sí, senza pensarci due volte. Questa, concluse, era l’impressione che emergeva tra tutte e lo rincuorava. Aveva scoperto dentro ognuno degli argonauti mancati, ritrovati dopo tanti anni, la gemma nascosta che si può chiamare in tanti modi: senso della giustizia e della libertà, o aspirazione verso un ideale di bellezza che si vorrebbe realizzare. Quella gemma, mancando stimoli dall’esterno, può anche opacizzarsi fino al punto da somigliare a un fossile amorfo, piú che a una pietra preziosa. Basta però una scintilla, un baluginare di luce che la raggiunga, e subito si mette a irradiare le sue magiche iridescenze, a dispetto dei registri e dei provoloni di Gragnano.
UNA CONVERSIONE
La luce della Costiera aveva una sua qualità che variava a seconda delle stagioni. Lo spettro luminoso, partendo dalla dominante color turchino, seguiva un ciclo di maturazione composto di varie fasi cromatiche: durante l’inverno la luce stagnava in un letargo di toni rosa e argento, percorsi dai brividi ramati dei crepuscoli, come un esotico e prezioso vermeil. A primavera, la luce mutuava dalla rinnovata germogliante vegetazione acerbi riflessi linfatici, diventava suscitatrice di sensazioni inquiete, di euforiche speranze, alimentando inesprimibili empiti interiori. Poi con l’estate i colori arrivavano alla loro pienezza: si caricavano di tutti gli umori emanati dagli elementi naturali: un lussureggiare di ori, porpore, smeraldi, uno sfavillio di riverberi nell’incessante e inesausto gioco che acqua, luce e materia intrecciavano nella prorompente vitalità del paesaggio. Fervore e completezza che si trasferivano nei temperamenti, facendoli esplodere in una disinibita corporeità, quasi che gli esseri umani, in sintonia con la natura, si lasciassero andare a uno scatenato saturnale nel quale bruciare energie fisiche, psichiche e pulsioni sentimentali sull’altare di una esigente divinità fescennina.
Quando poi il sacrificio era compiuto e la divinità appagata, quando finalmente l’umana frenesia estingueva i suoi residui fuochi, ecco arrivare settembre, prologo dell’autunno, con la sua luce di verità, né troppo intensa per ferire lo sguardo né troppo cupa per intristire, ma chiara nella sua radianza, gentile al contatto sulla pelle, delicata nel passare dall’esterno e raggiungere l’anima attraverso le pupille, toccare il cuore, la mente, indurre gli uomini alla serena considerazione delle cose e di se stessi. Tutto, in quella declinante luminosità ormai liberata da ogni forzatura cromatica, appariva cosí com’era. Sulle spiagge sgombre da invadenti e sfacciate anatomie unte all’olio di cocco, da pallonari estemporanei, da volgari praticanti di gavettoni, finalmente tornavano piú armoniose presenze umane, fragranze e umori recuperati dal tempo. Strade e piazze del paese riprendevano i bonari contorni e connotati di una familiare scenografia. Insomma, si ritornava a un piú armonioso ritmo di vita.
Quella luce settembrina di verità e temperanza di toni cominciò a filtrare dalle persiane socchiuse, illuminando la scrivania del professor Ignazio Filangieri: un vero campo di battaglia, ingombro di carte, tomi, fogli con appunti, ritagli di giornale.
Ogni anno, terminate le lezioni all’Istituto Tecnico Turistico dove insegnava storia e letteratura da oltre vent’anni, il professore si rifugiava nell’abbaino, adattato a studio, del casaletto rustico in cui abitava con l’anziana madre. Lí, nella quiete dei giardini di agrumi, tra i mille odori che venivano dalla terra, confortato dal cinguettio degli uccelli il giorno e dal frinire dei grilli la notte, il professore tentava di riscattare la sua cultura umanistica scrivendo un libro. Il suggerimento gli era arrivato dal preside dell’Istituto, Domenico Losurdo, che lo aveva convocato all’inizio dell’ultimo trimestre.
«Professor Filangieri – gli aveva detto, – se la sentirebbe di scrivere un saggio sulle Crociate?».
«Ma signor preside – aveva obiettato lui, – credo che non ci sia un tema piú usato e direi abusato di quello che mi propone…».
L’altro aveva sfoggiato un sorrisetto enigmatico:
«Ma io le parlo di Crociate viste in un’ottica molto specialistica, inedita…».
Filangieri aveva scosso la testa:
«Senza volerle sembrare saccente, ritengo che le Crociate siano state viste, esaminate e vivisezionate in ogni loro aspetto, da quelli piú palesi e positivi a quelli piú inquietanti e scabrosi».
«Sí, ma non in quello collegato alla nobiltà di questa regione…».
«Intende riferirsi alla partecipazione delle casate nobili di Pasidonia e dintorni alle varie spedizioni?».
«Proprio cosí. E se ne viene fuori un lavoro serio – e di questo sono certo date le sue qualità, – lo faremo adottare come libro di testo nelle nostre classi, e chissà, con l’intervento del Provveditore, anche in altre scuole della zona».
La proposta di Losurdo, operando una sottile seduzione intellettuale, lo aveva indotto a sperare in una possibile divulgazione del suo lavoro, e cosí, appena dopo quel colloquio col preside, si era dato anima e corpo alla stesura dell’opera.
Ma ora il bric-à-brac di carte e volumi che ingombrava la scrivania, messo a nudo dalla sincera luminosità settembrina, impietosamente denunciava che qualcosa non stava funzionando nella stesura dell’opera. E Filangieri sentiva che la causa era in lui stesso, di solito prolifico, rapido nell’ideare ed efficiente nell’esprimere i concetti che la sua immaginazione sapeva dettargli. L’estate era invece passata in un continuo scrivi e riscrivi, correggi e cancella. Qualcosa dentro di lui si era rifiutato di collaborare, lasciando la mano tristemente in attesa di suggerimenti, di quegli sprazzi di geniale intuizione che però non venivano. Il tavolo da lavoro appariva ora nel sole un grande, movimentato laboratorio, un cantiere in cui l’architetto aveva smarrito i piani di costruzione, oppure, avendoli, non era piú soddisfatto del progetto e non piú convinto che si dovesse portare a termine.
Eppure, la documentazione in suo possesso era di prim’ordine, eccezionale a dir poco. L’aveva ottenuta, oltre che dalle biblioteche locali e nazionali, dalle famiglie della Costa discendenti dalle casate patrizie che avevano preso parte alle varie spedizioni in Terra Santa, in particolare alle prime tre. Documenti conservati gelosamente, come reliquie, persino i libri dei conti, i diari di bordo, le lettere di carico: una messe impagabile di notizie, cifre e aneddoti. Ciò nonostante, Filangieri si era incagliato nelle secche dell’abulia creativa. Cosa gli era capitato?
Uno scampanellío lo fece riscuotere. Sua madre lo chiamava da basso per la colazione.
“Gesú – esclamò l’anziana donna appena lo vide. – Ignazio mio, sei impresentabile! Quei capelli ispidi… sembri il brigante Schiavone! Devi andare subito da Saverio. La settimana prossima inizia la scuola!».
Filangieri si avvicinò a sua madre e la baciò.
«Buongiorno mamma. Sí, andrò dal barbiere, lo avevo già deciso».
«Bravo. E come va col tuo libro?».
Mentre procedeva con il suo interrogatorio, la donna armeggiava ad apparecchiare per la colazione. Dalla caffettiera versò quindi il caffè, seguí il latte dalla lattiera di porcellana sbreccata ma antica, si diede a spalmare burro e marmellata sulle fette biscottate che estraeva da una biscottiera di latta. Non ricevendo risposta dal figlio, ripeté:
«Ti ho chiesto come va col tuo libro».
Di fronte a quell’incalzare, Filangieri estrasse dalla mano destra chiusa a pugno pollice e indice, e dopo averli puntati in direzione della donna a mo’ di pistola li fece oscillare piú volte. Cercò di sembrare il meno afflitto possibile.
«Mi sono bloccato – ammise sbrigativo – e non mi chiedere perché».
Il professore affondò una fetta imburrata nella tazza, la vide assorbire il liquido nocciola del caffellatte fino a spezzarsi in due. Col cucchiaino si dedicò al recupero della porzione colata a picco nel minuscolo oceano fumante.
«Te lo chiedo, invece – ribatté puntigliosa la donna, – perché uno non può trascorrere quasi tre mesi autosequestrandosi in un abbaino, per dire poi al mondo: “Scusatemi, non ho concluso nulla”».
Filangieri volle reagire:
«Questo non è del tutto vero… Qualcosa ho fatto!».
«E cioè?».
«Sono arrivato alla grande pestilenza di Giaffa, tra la seconda e la terza Crociata» annunciò esitante, e attese la reazione.
«Ma non sono sei, le Crociate?».
«Per la verità, sono otto».
«Ecco, lo dicevo io – replicò lei, girandosi di lato come volesse chiedere il consenso di un invisibile testimone, – non hai concluso nulla!».
Tacque per un attimo, poi soggiunse:
«Sono sconcertata, da uno come te, abituato a lavorare sodo e velocemente…».
Filangieri non raccolse le critiche. La sua mente, decollando a razzo dal rettangolo della tavola affollata di chicchere e posate, si era proiettata nel passato, in un formicolante scenario di putridume e morte. Poi, d’improvviso, con lo sguardo perduto dietro chissà quali apocalittiche visioni, cominciò a parlare lentamente:
«Sai, mamma, le Crociate non sono soltanto le imprese dei cavalieri senza macchia e senza paura che, spinti da Pietro l’Eremita, andavano a liberare il Santo Sepolcro. Nelle loro schiere si sono infiltrati personaggi senza scrupoli, animati da avidità e spietatezza. Accanto alle gesta esemplari ci sono state stragi, carneficine e distruzioni ingiustificate. Le tante contraddizioni e gli orrori che direttamente ne derivarono, come per esempio la peste di Giaffa, mi impediscono di proseguire e concludere con convinzione il lavoro».
La donna, sorpresa da quell’amara esternazione del figlio, osservò:
«Ma è la storia umana, caro Amedeo! La insegni da tanti anni, dovresti averci fatto l’abitudine. Voglio dire che non puoi lasciarti bloccare da uno smarrimento sentimentale. Non ha senso!».
Filangieri ignorò le considerazioni della madre e iniziò a descrivere:
«Immagina una prospera città sul mare: banchine portuali ingombre di merci e di lavoranti, navi all’ancoraggio che caricano e scaricano, un fervore di attività e traffici. Cosí è tutti i giorni. Nei fondachi del porto un brulichío di mercatanti e banchieri, cambiavalute, donne che acquistano o esaminano rare stoffe esposte sui banchi degli empori rigurgitanti di spezie, profumi, chincaglierie e preziosità d’ogni genere. Ma in agguato c’è lei, la tumefatta deità mortifera: la peste».
«Ti prego, Amedeo – supplicò la donna interrompendolo, – non a colazione… La peste!».
Ma ormai Filangieri non era piú in grado di mettere le briglie alla fantasia che lo trascinava lungo le brumose vie del passato:
«Vedi, mamma, nessuno sa come inizia veramente un’epidemia. Ce ne accorgiamo soltanto quando si è ormai già diffusa in un consesso umano. Il batterio che la scatena è lí da sempre, latente, assopito in una sorta di letargo che può durare anni, decenni, secoli. In potenza è terribile, ma quel sonno, indotto da un ignoto meccanismo inibitorio, lo rende inerte, inoffensivo. Poi, un giorno, anzi, un attimo di un dato giorno, lo stesso meccanismo che lo ha tenuto inoperoso, coatto, di colpo lo risveglia, inducendolo ad agire per infettare e uccidere. Quel comando, impartito dall’ignota volontà, lo trasforma d’un tratto da passivo e apatico in virulento e aggressivo, da stanziale in erratico. Ed ecco l’epidemia dilagare, e quegli uomini e quelle donne fino a pochi attimi prima intenti alle attività di un’esistenza dinamica e gratificante, vengono raggiunti dalla violenza spietata del morbo, si ammalano e rapidamente muoiono…».
«Libera nos a malo!» recitò la donna, segnandosi.
Imperterrito, Filangieri proseguí:
«La domanda che uno deve porsi è questa: come ha potuto il virus, da inerte e inoffensivo, tramutarsi in letale e aggressivo? Qual è il quid che lo ha portato alla nefasta mutazione, alla metamorfosi maligna, e perché è stato scelto un dato luogo e un determinato periodo, anzi quel particolare istante? Pure, le condizioni ambientali sono le stesse di sempre, gli umori che la gente scarica nell’aria, nell’acqua, nelle fognature, sono quelli di ogni giorno, con le medesime caratteristiche biologiche e biochimiche preesistenti all’avvento dell’epidemia. E allora? Quale occulta distonia degli elementi entra in gioco?».
Filangieri si sporse verso la madre, sollecitando una risposta che non venne. La donna, letteralmente allibita al discorso del figlio, abbozzò un timido:
«Non lo so, proprio non riesco a immaginarlo…».
«Il fatto è, mamma, che non lo sa nessuno. Tutti gli esperti individuano il morbo dopo che ha dato inizio alla sua opera di distruzione. La combinazione dei fattori scatenanti rimane un mistero».
La frustrante conclusione aleggiò nella stanza e chiuse i due in un cupo mutismo. Ruppe il silenzio la donna, dopo qualche attimo:
«Sai cosa penso, Ignazio? La mia idea è che quando uno lascia la strada maestra per imboccare vie e viuzze secondarie, ingolfandosi nelle strettoie dei dubbi, nello studio dei particolari insignificanti, vuol dire che non ama il soggetto che sta realizzando, sia esso un libro, un quadro, o un lavoro di creazione artigianale. Si vede che le Crociate, con tutte le atrocità e le miserie della guerra, col sovrappiú delle epidemie, non sono esattamente la materia che ti sarebbe piaciuto trattare. Non ho ragione, forse?».
Filangieri non rispose. Era intento a scrutare il fondo della sua tazza vuota. Il liquido vi aveva lasciato una gora che formava un disegno strano: un’aquila… una farfalla… o era magari il piú subdolo e iniquo virus della peste che si delineava sinistro e indecifrabile, usando l’innocente residuo del caffellatte?
La donna si rese conto che doveva cambiare atteggiamento e scuotere il figlio dal marasma in cui lo vedeva impantanato:
«Insomma, Ignazio – disse con fare energico, – queste Crociate avranno pur avuto qualcosa di bello e di esaltante in mezzo a tante rovine e stragi. In definitiva erano ispirate da santi princípi e grandi ideali. Fra migliaia di uomini armati di lancia e spada, ci sarà stato qualcuno che le abbia vissute con lo spirito di un vero cristiano!».
Filangieri interruppe l’esame dei fondi della colazione e spostò lo sguardo in direzione di sua madre. Era piacevolmente sorpreso.
«Certo mamma, ci furono esempi di santità e di sacrificio disinteressato… Uno in particolare, un figlio di Pasidonia…».
«Oh, finalmente! – esclamò la donna visibilmente sollevata. – E chi era quell’anima nobile?».
«Hai detto bene, perché proprio di un nobile si trattava, di nome e di fatto: il beato Gelasio da Pontalto, al secolo Onorio dei Montefoschi».
«Ma non è quello dell’unguento miracoloso, delle guarigioni impossibili per le affezioni della pelle, che è sepolto su alla Certosa di Pontalto?».
«Già, proprio lui. Venne inviato a difendere il Krak di Belvoir, una fortezza costruita dai Pasidonesi dopo la prima Crociata, sulla strada fra Giaffa e Damasco. Cerchiamo di immaginare lo scenario. Siamo nell’anno 1165. La seconda Crociata è ormai un ricordo, essendosi conclusa nel 1151. Onorio è giovane, ha venticinque anni. Primogenito del marchese dei Montefoschi, è coraggioso e leale: vuole portare alla casata onori e titoli ma, da autentico cavaliere, è allo stesso tempo animato dalla consapevolezza della sacra finalità dell’impresa. Ignora quindi i risvolti meschini e le viltà di cui si sono macchiati alcuni tra i Crociati come alcuni tra i musulmani. Per lui la difesa del Forte garantisce la sicurezza della contea di Giaffa e Ascalona, voluta dal Buglione dopo la Prima Crociata, e protegge le colonne di pellegrini che a piedi, via Anatolia, o sbarcati a Tiro, Sidone o Giaffa, si recano a Gerusalemme. Ma gli islamici si stanno riorganizzando, sotto la guida di un grande condottiero: Salah-al-Din, il famigerato Saladino, il quale con ingenti forze, nel luglio 1169, attacca il Krak di Belvoir e dopo un massiccio assedio e aspri combattimenti lo conquista, mettendolo a ferro e fuoco. Onorio e gli altri cavalieri si sono battuti disperatamente, al limite dell’umano. Ma le forze del Saladino sono soverchianti. Quando Belvoir cade, Onorio, insieme a pochi superstiti, evita la cattura da parte dei musulmani e si rifugia a Giaffa. La città è invasa dai fuggiaschi e dai pellegrini, vi portano i feriti dai campi di battaglia, promiscuità e disordini sono ovunque, uniti alla calura e alle carenze igieniche. A causa di tutto questo, ma anche e forse piú per lo scatenamento di quelle forze occulte di cui parlavo prima, scoppia la terribile pestilenza. La terra è stanca e satura per gli eccidi, i massacri, le distruzioni da una parte e dall’altra dei contendenti. Cinismo, crudeltà, sete di vendetta, cupidigia, viltà, tradimenti hanno rotto l’equilibrio che regge gli elementi della natura. Onorio si spoglia dell’armatura e della spada per indossare il saio del penitente misericordioso e la croce della carità, dell’amore verso i miseri e gli infermi. Si uniscono a lui altri cavalieri, e poi medici, artigiani, marinai. Nasce cosí l’Ordine dei Barellieri di Giaffa, diventato poi Ordine dei Santi Cosma e Damiano, e in seguito, ormai terminate le Crociate e caduta in mano islamica Agri, ultimo baluardo della cristianità in Oriente, diventa Compagnia dei Cavalieri di Cipro. Ovunque ci fosse una battaglia o un’epidemia, Onorio, diventato ora fra’ Gelasio, accorreva con i suoi compagni e soccorreva, medicava, curava, sfamava, seppelliva i morti dell’una e dell’altra parte, senza distinguere tra ceto, razza e religione».
«Bello, edificante! – fu il commento spontaneo della madre, non appena Filangieri ebbe terminato il suo excursus storico. – Ma allora, scrivi un libro su fra’ Gelasio da Pontalto…».
Il professore scosse la testa:
«No, non è possibile. Ho preso un impegno con il preside… come faccio adesso? Dovrei andare da lui e dirgli: “Invece che la storia delle Crociate preferisco scrivere quella di un cavaliere diventato frate per una crisi esistenziale, e che si è dato poi alla terapeutica e all’erboristeria…”. Te lo immagini quel miscredente di Losurdo come commenterebbe? “Bravo Filangieri, adesso mi racconta anche la vita dei trappisti. Ma è proprio esaurito!” Ecco quello che direbbe Losurdo. E forse avrebbe ragione».
«No, non avrebbe ragione…».
La donna si alzò dal suo posto per avvicinarsi al figlio:
« Senti – disse pacata. – Vorrei fare qualcosa per te. Mi accorgo che sei tormentato da questa vicenda del libro, e forse anche da qualcosa di piú serio».
«Ma no, mamma – reagí lui – vedrai che in un modo o nell’altro lo finirò, il libro!».
Poi il suo sguardo tornò a scandagliare il fondo della tazza vuota. Ora la gora lasciata dal caffellatte disegnava una specie di fiore dentellato. Sua madre lo richiamò alla realtà passandogli le dita tra i capelli incolti. Poi soggiunse, in tono disteso:
«Il fatto è che non si dovrebbe mai lavorare, in arte, in letteratura o in qualunque altra attività creativa, sotto la pressione della committenza, o per semplice fine di lucro. Vorrei farti vedere qualcosa».
Con passo deciso, nonostante l’età, la donna si avviò verso il suo studio. Dopo qualche attimo, Filangieri udí il cigolio familiare del carrello sul quale era montato il cavalletto di pittura che sua madre adoperava per spostare le sue tele da un punto di luce a un altro della casa mentre dipingeva.
La donna ora spingeva il carrello con delicatezza e religiosa cautela. Filangieri accennò ad alzarsi.
«No – lo fermò lein – non ti muovere, lo porto lí, vicino alla tavola. Aspetta!».
Quando fu presso il figlio, fece ruotare il cavalletto in modo che lui potesse meglio osservare il quadro.
«Ecco, cosí. Beh, che ne dici?».
«Ma è…» stava per dare un titolo al dipinto, quando sua madre lo anticipò con slancio:
«È l’Eden riconquistato, nella mia personale interpretazione. Mi interessa molto il tuo giudizio» e restò in attesa, con una mano a reggere il cavalletto e l’altra a ravviarsi i capelli grigi che si ostinavano a caderle sulla fronte sudata per l’eccitazione.
Non si trattava di una scena alla Masaccio con Adamo ed Eva cacciati fuori dal giardino incantato delle origini dopo aver mangiato il frutto dell’albero del Bene e del Male, fustigati da angeli librati in volo. Invece di apparire disperati e nudi, in fuga precipitosa e allo stesso tempo riottosa per quanto si lasciavano alle spalle, qui i protagonisti della figurazione, rappresentati tra fiori variopinti, si mostravano appagati e sorridenti ai lati dell’Albero della Vita ricolmo di frutti dorati. In un angolo, il serpente tentatore si stava lentamente metamorfosando in uno splendido uccello del paradiso. La rara abilità dell’autrice aveva perfettamente reso la graduale trasformazione delle squame cenerine in fantasmagoriche piume. La prodigiosa mutazione culminava nel viso umano della strana creatura, non piú viscido rettile ma essere angelico, benevolmente sorridente e rivolto verso i suoi redenti amici, prima di essere riassorbito dal mistero cosmico.
Filangieri restò affascinato in particolare dalla resa espressiva della metamorfosi.
«È il Serpente piumato – si affrettò a spiegare la madre. – Mi sono ispirata a un affresco messicano pubblicato su una rivista di archeologia».
«Sí, lo conosco. Rappresenta il Quetzalcoatl – disse Filangieri, – una divinità dell’antico popolo Tolteco, l’unica che non richiedesse sacrifici umani, ma solo offerte di fiori e frutta. Si turava le orecchie per non udire i rumori della guerra e voleva le creature umane miti e pacifiche, dedite ai lavori della terra e alle arti. Ma un giorno, stanco delle violenze degli uomini, distese al vento il suo mantello piumato e scomparve verso il mare, dopo aver promesso che sarebbe ritornato quando gli uomini fossero divenuti migliori».
«Sta per tornare…» disse ispirata la donna.
Il figlio le rivolse uno sguardo interrogativo.
«Sta per mantenere la sua promessa – insistette lei, – e tutto il male si trasformerà in bene. Lo dicono le antiche profezie: il mondo esce dal Kaliyuga per entrare nel regno dello Spirito. Giungerà un tempo di tregua durante il quale il Male non potrà nulla contro gli uomini».
«Vorrei proprio che fosse cosí, mamma. Ma non riesco a crederlo possibile. Comunque il tuo quadro è bello, ispirato, anche se alquanto audace…».
«Grazie – fece lei tranquilla, – ma non è la gloria pittorica che mi interessa, alla mia età poi! Vorrei solo darti un po’ di fiducia nel futuro. Vedo che ne hai bisogno».
«Non ti preoccupare, andrà tutto bene, mamma – la rassicurò lui sorridendo. – Vedrai che alla fine terminerò l’opera. Spero solo di scrivere un libro capace di dare speranza alla gente che lo leggerà, specialmente ai ragazzi della scuola».
Tacque, esitando un attimo prima di aggiungere:
«Per la verità ignoro di cosa veramente abbiano bisogno i giovani… e anche tutti gli altri, in un momento come questo».
«La soluzione verrà da sé – confermò decisa la madre. – Noi dobbiamo solo credere che il serpente diverrà finalmente araba fenice, o uccello del paradiso. Cosí è scritto e cosí sarà».
Poi, mentre il figlio assorto sembrava meditare sulle sue parole, la donna soggiunse, misteriosa:
«Sai, ci vengono mandati segnali tutti i giorni, dappertutto sulla terra, per dirci che il tempo della grande metamorfosi è vicino. Ma noi, per pigrizia, distrazione, superficialità e persino arroganza, non cogliamo gli avvertimenti. Anche qui a Pasidonia ce ne sono stati…» e avrebbe voluto continuare, ma lui, il professore, correva già dietro a qualche suo arzigogolo cerebrale e non prestava piú orecchio.
La madre, rassegnata, troncò il discorso e, salutandolo, si raccomandò in tono scherzoso:
«E non farteli tagliare troppo corti i capelli, perché Saverio, quando attacca a parlare di sport o di politica, è capace di raparti a zero, distratto com’è!».
Filangieri assentí alla raccomandazione materna, ma era tutto inutile. Tanto Saverio, che fosse sport, politica o musica corale, si sarebbe comunque lasciato prendere dalla foga, e giú con le forbici a fare giustizia della sua arruffata chioma.

