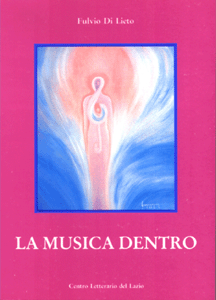
Ed. Centro Letterario del Lazio, Roma – 1988
La musica dentro
TASTI NERI
Notte sul mare
«Terra moriens» a Brema
La Giostra
La segretaria
Le chiavi
Cercasi
Fast food
Il frutto
La quercia e il vento
Il cieco
Esodo
Per amore
Lezione di scienze
L’Imperatore
Versailles
Waterloo
Il torrente
Il pianto
L’intesa
Il castello
Alla madre
Uomo del Sud
A Manzoni
TASTI BIANCHI
Calendimaggio
Cose fatue e leggere
Sulla riva
Promesse
Sortilegio d’aprile
Notte
Così ti cerco
La casa di Livia
Mattutino (orti di Numa)
Segesta
Calabria
Beatitudini
Speranza
LA MUSICA DENTRO
La musica dentro
compagna di via
del cuore nel centro
compone armonia:
scandisce le ore
di mille stagioni,
lenisce d’amore
le tante illusioni.
Ti prende per mano,
ti parla, ti guida,
ti porta lontano
durevole e fida.
Ascolta: la senti
seguire i tuoi passi,
se mai tu rallenti
per trappole o sassi.
La musica forte
continua a suonare,
sfidando la sorte
che mira a disfare,
beffando la morte
che vuole trionfare.
Ascolta: la senti
vibrare in assolo
con toni possenti,
con slanci di volo.
La musica dentro,
compagna dell’Io,
dell’Ordine il centro,
respiro di Dio.
NOTTE SUL MARE (Minori)
L’aria è una corda tesa:
vi cammina
una luna funambola
che oscilla
disperdendo particole
d’argento
nell’acqua buia
al fondo della notte.
Domani ce ne andremo,
ma ricorda:
questa casa ebbe vita
al tempo antico.
Nelle notti di giugno
la serena
purificava gli abiti,
e l’infuso di petali
al mattino detergeva
ii tuo viso, salvandolo dal male.
Vaticini forniva
il piombo fuso
rappreso in forme arcane
al davanzale.
Ubriaca la luna caracolla
in groppa a cirri laceri
che ai monti
s’impigliano
stremati
a tronchi e rami
spettri scarniti
in madidi grigiori.
Il buio
è un pozzo asciutto
disertato
da lucciole e falene
e le farfalle
non allietano al sole
la Pawlonia
che incenerì
la folgore di marzo.
Domani ce ne andremo,
ma ricorda:
ebbero cuore un tempo
queste mura
per ascoltare voci
di sirene
che ora son venute a salutarci
in afoni drappelli
scarmigliati
mostrando i corpi rosi
dalla peste
che vinse il mare,
spopolò le rive
di barche
e reti,
desolò la terra.
L’aria è una corda tesa:
la percuote
invano l’ostro
per destarne un canto.
LA SEGRETARIA
Un giorno, Lisa, quando avrai più tempo,
spolvera il pothos lì nel corridoio
e guarda fuori, oltre la finestra,
oltre la grata che ti nega il cielo.
Quando distolto avrai gli occhi tuoi stanchi
dalle schede forate, le scadenze,
e rotto l’ipnotismo del computer,
guarda quel cielo chiuso dalla grata:
s’illumina di led celeste chiaro
che Dio alimenta con la Sua energia.
Un giorno, Lisa, se ti fermerai,
solleva il capo da fatture e mastri,
metti una rosa tra i capelli neri,
magnetizzati, ispidi, laccati,
gretta parrucca di pupattolina
ridotta in tilt a fine settimana.
Spegni lo schermo, rompi quella grata
e con le schede forma un aquilone,
un castello di carta, un aeroplano,
un cappello da clown, una barchetta.
Scavalca il muro della tua prigione,
brucia i circuiti con un gran sorriso,
un canto a squarciagola, una preghiera.
Guardalo, un giorno, Lisa, quel tuo cielo,
spolvera il pothos diventato grigio,
sciogli la chioma che non ha più luce.
Affacciati al balcone della vita,
metti le ali della primavera
e vola a coltivare il tuo giardino
germogliato di nuvole e di stelle.
LA QUERCIA E IL VENTO
Oggi mi sento debole e smarrito.
I figli sono andati per il mondo.
Sono una vecchia quercia senza appigli
e sostegni che reggano il mio tronco
gibbuto, cavo, ruvido, contorto.
I figli sono andati come i semi.
Feconderanno grembi e avranno figli.
Così la vita mi dà ricompensa
d’aver riempito il mondo ed esser solo
come una quercia all’orlo di un dirupo.
E viene il vento a mietere le foglie
unite ai rami, ma d’altra stagione.
Verde reclama verde, ed io son stanco,
pianta depauperata d’ogni linfa.
E cala il vento la sua falce e miete
l’albero scisso dalla sua radice.
Oggi mi sento lieve come piuma
e basterebbe un soffio a farmi alzare
da questo mondo che non m’appartiene,
come s’invola un fragile aquilone.
I figli sono andati, e chi mi aiuta
a guadare la piena della vita,
i vortici e la torbida corrente?
Sono andati felici all’altra riva,
le mani loro unite ad altre mani,
le care voci miste ad altre voci.
Oggi mi sento orfano e confuso.
Vorrei qualcuno che mi sorreggesse,
ora che affronto il guado ad altra vita.
Oggi che il vento vibra sibilando
la sua falce ricurva sul dirupo.
LEZIONE DI SCIENZE
La rana è stesa lì sul tavolaccio,
quattro spilli la tengono bloccata,
uno per ogni zampa, e il professore
trancia giudizi sull’anatomia,
parlando di riflessi e magnetismo,
elettroconduzione e gravidanza.
Tra poco inciderà l’addome e il petto
per scoprire i segreti del diaframma
le connessioni, i tendini, le molle
per cui la rana nasce, salta e muore.
Manca poco allo scempio e la bestiola
con gli occhi acquosi sta mirando il cielo,
dove frullano voli e brilla il sole.
Un riflesso le accende la memoria:
ricorda la corrente di un ruscello
dove nuotava tra la menta fresca
e l’erba nuova della primavera.
Ma non c’è tempo per i bei ricordi,
il bisturi volteggia e manda lampi,
ancora un soffio e poi sarà finita.
La rana, allora, come il condannato,
chiede agli Dei l’estremo desiderio:
d’imitare i carnefici e parlare.
Pietoso il Cielo accorda quella grazia
a un’anima ormai prossima alla fine
per mano di creature raffinate
che hanno svenduto il cuore per capire.
Mentre il coltello penetra la carne,
l’anfibio esclama con umana voce:
« Perdona loro, Padre, questo danno,
metto la pelle mia nelle Tue mani,
e abbasso Volta, Franklin e Galvani ».
WATERLOO
Gli uomini, morendo, fioriranno;
la guerra è solo un gioco e non lo sanno.
Vibrano spade, spronano cavalli,
ma appena nella terra i loro corpi
diventeranno semi rosso cupo
a fecondare i solchi e le brughiere.
Qui ora il tempo ha spento il vorticare,
placata l’onda, l’impeto, lo slancio,
sedato l’urlo, incenerito il sangue.
Pedoni, alfieri, re, cavalli e fanti
sono spariti dalla gran scacchiera
che ora è un prato fresco di maggese.
Resta un’asperità che svetta in alto
dalla campagna a freccia verso il cielo
e un leone di pietra vi troneggia
a ricordar chi vinse la partita.
Ma vinti e vincitori sono semi,
fecondano la terra e non lo sanno,
appena morti entrano nel gioco
sublime e lieto della primavera.
Ora son lì a gremire le pendici
della collina dove finì il gioco
di vita e morte, e sono tutti fiori.
Schiere di margherite, crochi e viole
ascendono la china ripetendo
nel vezzo dei colori quelli antichi:
coccarde, gagliardetti, insegne e piume,
alamari, bandiere, nastri e fiocchi:
kepí fregiati d’oro e le feluche.
Ora son fiori umili e confusi
che il vento scuote nell’estremo assalto:
ecco sciabole d’erba saettare,
issano i fiordalisi un gran pavese,
guizzano in lampi viola cardi e spighe
prossimi a conquistar l’ultima balza.
Premio al furore e all’impeto silente
non è la barricata, la trincea,
un cannone da prendere di slancio:
è il cielo chiaro oltre quella cima.
IL TORRENTE
Settembre è ancora dolce, camminiamo
seguendo il corso antico del torrente.
Ci porterà, ricordi, a quella valle
dove nei giorni di vacanza a scuola
andavamo a raccogliere mirtilli,
le more che pungevano le mani,
l’asparagina tesa come spade
e la rosa canina che serbava
il dono del suo miele nello stame
geloso come l’oro in un forziere.
E l’ila s’affacciava alla ninfea,
come una principessa al suo verone,
fiera del loto candido di neve
ed era la più bella del reame.
Ma un giorno venne il mago del cemento
che muta in calcestruzzo la natura
soltanto che la sfiori con un dito:
quel nostro Sbangrilà è un falansterio
di condomini, ville, agglomerati,
e nel torrente scorrono liquami
tra un frigo rotto, un materasso a molle,
un grosso scaldabagno, una poltrona
ed un bidet con rubinetteria.
Un brutto sogno, o forse un sortilegio
che tramutò la principessa in rospo
e il nostro Paradiso in pattumiera.
L’INTESA
L’oasi è illuminata dalla luna.
Wadi Rum è il suo nome, l’hanno scelta
per un incontro a due tra Governanti:
un capo religioso ed un monarca.
È top secret il luogo, e le intenzioni
di questo abboccamento tra i palmeti,
dove nell’acqua tremula dei pozzi
a notte si riflettono le stelle
e bevono gli armenti quando è giorno.
Evoca Wadi Rum tempi lontani
di vita pastorale beduina,
di carovane e traffici di spezie.
La via del franchincenso e della mirra
attraversava questo sito ameno
che a tutti dispensava ombra e ristoro.
Sono venuti all’ora stabilita
con una scorta d’uomini fidati,
avvolti in barracani col cappuccio,
ordini secchi, frasi misurate.
«Spero che non mi abbiano seguito»,
dice il monarca, a guisa di saluto.
E l’altro gli fa eco preoccupato:
«Lo spero anch’io, non ci si può fidare.
I tempi sono duri ed i nemici
crescono come funghi dappertutto».
«Lievita il malcontento nel mio regno:
disoccupati, senza-tetto, ladri
spinti dalla miseria e dalla fame
s’organizzano in bande di predoni.
La gente è in mano dei sobillatori»,
si duole il re, e l’altro di rimando:
«Che dovrei dire allora del Paese
che governo nel nome del Profeta.
Sviluppo demografico, inflazione,
carenze di strutture, malcontento,
l’inedia è un passatempo nazionale».
«Avevamo puntato sul petrolio
la carta del riscatto e del progresso»,
aggiunge il re, scuotendo il cappuccione.
E l’uomo santo, dimenando il suo:
«Non me ne parli, quella del petrolio
è stata un chimera, un controsenso.
Entrano i soldi ma non resta niente;
tutto il guadagno che dà l’oro nero
lo spendiamo in acquisti di derrate,
generi di consumo, attrezzature,
persino l’acqua è un bene da importare».
Un consigliori mostra l’orologio.
«Il tempo stringe, Santità, veniamo
al punto chiave dell’abboccamento.
Ho predisposto un piano con esperti:
non dovrebbe fallire. Glielo illustro.
All’ora X scatta l’attentato
alla stazione della capitale.
Per convenienza e per ridurre i costi,
noi lo si fa, voi lo rivendicate.
Tre giorni dopo voi fate lo stesso:
tre cariche esplosive alla moschea
nell’ora di preghiera, e addebitate
a noi vigliacchi l’efferato gesto.
Seguiranno incidenti di frontiera
con incursioni, scaramucce e morti,
che attizzeranno l’odio e la vendetta ».
«Ma che diranno le superpotenze?»
obietta il sufi, e l’altro lo rincuora:
«Tutto previsto, tutto calcolato.
Godiamo dell’appoggio e della stima
delle nazioni più civilizzate
che forniranno vettovaglie ed armi.
Una guerra ad oltranza è benvenuta:
noi dimezziamo il popolo e i problemi,
e loro sperimentano i modelli
di nuovi ritrovati militari,
le tecniche d’impiego, le gittate
di missili e cannoni. Che le pare?»
«Un piano astuto, che non fa una piega,
ed io l’approvo senza una riserva
– conviene il religioso, e poi soggiunge –
potrei sapere a noi che ce ne viene
oltre al vantaggio di sfoltire il volgo? »
« Credito illimitato dalle banche
in conti personali, in appannaggi,
prestigio in seno alle Nazioni Unite,
prestiti con lo sconto, investimenti
nell’edilizia e nell’agricoltura.
Chi non diventerà carne di porco
sotto le bombe e i cingoli dei carri
vivrà felice come il Saladino».
« I morti anch’essi non saran da meno,
– precisa l’uomo santo – ché il Profeta
a tutti garantisce il Paradiso:
chi muore combattendo nel suo nome
trova dall’altra parte ricompensa
d’ineffabili gioie corporali
in compagnia di musici e donzelle,
bevendo latte e miele a profusione».
«Come Lei vede, ce ne sta per tutti.
Ed ora, Santità, leviamo il campo;
reciti ognuno la sua parte in tono
con quanto stabilito dal copione.
Lei poi mi scuserà se qualche volta
in un discorso le darò del ladro,
dell’impostore, del cappio da forca».
«E lei non se la prenda se ribatto
chiamandola cretino e farabutto,
o qualcos’altro che mi verrà in mente
quando ritorcerò le contumelie.
Restiamo sempre amici, come prima».
«Vorrà dire nemici, e per la pelle!»,
precisa il re, in tono spiritoso.
«Oh già, dimenticavo, il ruolo è ruolo!»
celia il santone, mentre s’accomiata.
E come son venuti, così vanno,
con poca scorta nella notte fonda.
La luna è tramontata nel deserto,
oltre i palmeti, dietro quelle dune.
Trema l’acqua nei pozzi: quei presagi
di morte e sangue l’hanno intorbidata
offuscandovi l’oro delle stelle.
IL CASTELLO
La visita comincia dal cortile.
« Quello che qui vedete è, tra i castelli,
esempio di mirabile armonia.
Vi lavorò Sangallo, e poi Bramante,
Del Piombo, Buonarroti e Vanvitelli ».
Il cicerone recita la parte
guidando il gruppo su per la salita.
« Notate la possanza dei bastioni
cui pose mano, a fine quattrocento,
il Duca Sigismondo detto il Fiero,
chiedendo il meglio e non badando a spese ».
« Cosa sono quei buchi lassù in alto? »
domanda ignaro uno dei turisti.
« Bocche da fuoco per l’artiglieria
che sparavano palle di granito
pesanti mille libbre cadauna ».
« E quelle feritoie a taglio sgembo? »
« Sono bocche di lupo, micidiali
per far colare pece ed olio a doccia
sugli assedianti prossimi al portone ».
Il cicerone non demorde e cita:
« Notate l’architrave a tutto sesto,
il bugnato snellito da motivi
che richiamano l’estro raffinato
dei maggiori palazzi fiorentini.
E che dire dei muri rastremati,
dell’eleganza di torrioni e merli ».
Il gruppo ammira, si sorprende, osserva.
« M’incuriosisce il cippo là nel mezzo »,
insiste dalla folla un’altra voce.
« Serviva alle condanne capitali
per mozzare la testa ai condannati.
E sullo sfondo s’aprono le celle,
senza finestre, senza prese d’aria.
Le stanze di tortura e le segrete
munite d’ogni sorta di strumenti
per estorcere abiure e confessioni ».
Ora la comitiva è nel salone
festonato d’arazzi e di trofei.
« Questa è la grande sala delle feste,
con la volta affrescata dal Giorgione,
e gli arazzi tessuti nelle Fiandre
sono il fiore all’occhiello del museo.
Pregevoli gli armadi e i cassettoni,
i lampadari e la tappezzeria ».
« Ma qui vedo una macchia rosso cupo,
anzi, son tante, e impregnano la stoffa ».
« Dimenticavo, quelli sono i segni
di Sigismondo quando fu colpito
da venti pugnalate a tradimento
per mano di sicari prezzolati
da suo cugino, duca di Provenza.
Morì sul colpo, e dopo la congiura
s’estinsero la stirpe ed il casato.
Seguirono nel tempo altri padroni,
governatori, vescovi e marchesi,
che accrebbero di fasto e di ricchezze
il già cospicuo patrimonio avito,
chiamando artisti, letterati e bardi
che dessero al castello gloria e lustro ».
« E le segrete? » chiede un ostinato
visitatore con un groppo in gola.
« Funzionarono sempre, senza posa.
S’adeguarono ai tempi, migliorando,
aggiornando i sistemi e i macchinari.
Vennero usate fino al dopoguerra
come prigione per gli ergastolani ».
La comitiva va per gli scaloni,
osserva, si stupisce, si costerna.
La precede solerte il cicerone
e parla, spiega, cita ed erudisce
sul luogo che sposò morte e bellezza.
« Ed eccoci, signori, all’armeria,
con archibugi, mazze ed alabarde,
schioppi, spingarde, obici e balestre,
per non parlare di pugnali e stocchi,
armi varie da taglio, punta e lancio.
Ma il pezzo forte della collezione
è formato da tutte le armature.
Questa ad esempio, fatta a Norimberga,
apparteneva al duca Sigismondo,
che l’indossava quando combatteva,
il che voleva dire tutti i giorni.
Era una schiatta, quella, di guerrieri,
nata per conquistare mari e monti.
Completo di corazza, lancia e scudo
pesava Sigismondo mille libbre:
lo si poneva in sella col paranco.
Formava col cavallo un carro armato
che stritolava schiere di nemici
senza misericordia né quartiere.
Ma quando terminava la battaglia,
il duca vincitore s’allietava
con musici, buffoni e cortigiane
che aveva sistemato in un quartino
poco lontano dal suo appartamento.
Così si distraeva, e se gli andava
appagato dal vino e dai sollazzi,
poteva anche graziare un prigioniero
dando l’esilio in luogo della morte ».
La visita è finita, il gruppo sciama,
ritornando all’aperto, in piena luce.
Un bambino ritrova il suo coraggio
e chiede al padre senza complimenti:
«M’hai sempre raccontato che i castelli
ospitavano fate e cavalieri
senza paura, macchia e ipocrisia;
ch’erano luoghi dove si menava
esistenza felice e spensierata,
tra feste, balli, serenate e canti.
Non m’hai parlato di pugnali e sangue,
delle segrete e stanze di tortura.
Come stanno le cose veramente? »
Il padre tace preso alla sprovvista.
Imbarazzato, replica alla fine:
« Non parlavo di un simile castello,
il mio si trova nella fantasia ».
Il figlio si rassegna, ammutolisce.
Da oggi non è più quello di ieri,
ha veduto il rovescio delle cose,
perdendo con i sogni l’innocenza.
Tutto d’un colpo è diventato uomo,
dimenticando fate e cavalieri.
ALLA MADRE
Le fresie hanno precoce fioritura
sopra il balcone dove siedi assorta,
il mare calmo alita fragranze
e l’aria ti stordisce con odori
destàti alla memoria da ricordi
di stagioni del vino e delle rose.
Avevi chiome d’ebano, rammenti,
di pesco colorava giovinezza
le tue gote e la bocca di corallo,
tessevi canti, avida d’amore,
e il sorriso negli occhi rifletteva
i vibranti asterismi delle stelle.
Ora tu vivi consumando brani
di tempo sonnolento, sospirando,
e scruti il mare in cerca di una vela
sognando che riporti giorni lieti,
le spente voci, le carezze avare,
luce corvina nei capelli alteri.
O speri che le torri di vedetta
levino all’alba grida di saluto
per il viandante prossimo alle mura,
vinto dagli anni e dal peregrinare.
Ma le torri son mute, madre mia,
le mura sono cumuli di sassi,
stanca è la mano a tessere la tela,
la gòmena corrosa e vuoto il mare.
Placa il tuo cuore, ché nessuno approda
per battere il suo nome alla tua porta.
UOMO DEL SUD
Io sono quel che sono: cuor di fiele,
frutto di rovo, sangue di serpente,
lingua d’aspide, faccia di brigante.
Io sono quel che sono, irsuto e schivo,
prono alla terra, avanzo di caverna,
omo ferino, bruto, latitante
nelle nobili imprese e disertore
d’ogni storica istanza, ciarlatano,
venditore di fumo, cabalista,
cerusico di piazza, parolaio,
tre palle un soldo, tratto da magliaro,
svelto a carpire e lento nel donare.
Ma sono quel che sono, non mi pento.
Io sono il cactus nato alla pietraia
nel connubio tra polvere e calcina,
spinoso, infido, traditore e baro,
carne di porco da tritare in guerra
per sfamare l’orgoglio nazionale.
Io sono quel che sono: l’emigrante,
il tappabuchi, l’orso ammaestrato
che ha ballato per secoli al guinzaglio
di preti, duchi, vescovi e baroni.
Bestia del latifondo o plebe infame,
affogata nei vicoli sorcini
delle grandi metropoli regali.
Eccomi a voi signori come sono:
eterno postulante lacrimoso,
piagnone inveterato, guitto amaro,
nato dal niente e senza niente in mano,
povero in canna, malfidato, sporco,
afflitto da ogni male, camorrista,
languido chitarrista strappacore,
sempre impegnato a darvi la patacca.
Questo son io, e sono come sono,
uomo del Sud, eterno saprofita
dell’opulenza altrui, dell’altrui scienza,
empirico altrimenti e improvvisato.
Parente da ricevere in cucina
e ripulire coi vestiti usati,
proletario indolente, piantagrane.
Questo son io: rampollo di briganti,
lingua d’aspide, sangue di serpente,
foglia d’ortica, agave contorta
che mette fiori solo per morire.
CALENDIMAGGIO
Non tradisce, l’acacia: la ritrovi
fedele ad ogni maggio che ristora
clivi diruti, putridi sterrati
con verde nuovo e levità di fiori.
Bianco è il tempo che viene e virginale.
Il vento passa risvegliando semi,
scuotendo i nidi in cima ad alte torri.
Colgono il cuore stordimenti d’aria,
vertigini di voci, odori e suoni.
Adesso è il tempo di lasciarsi andare
saggiando il vuoto con le prime ali,
preda di spazi e vortici di voli.
Abbandonarsi al cielo, alla sua pace.
COSE FATUE E LEGGERE
Passò così l’estate: la cicala
dissipando le ore celebrava
vita frivola e breve nella trama
del suo pensile regno, e s’inebriava
l’uomo legato a un’ala di farfalla
volteggiando tra iridi e vapori.
Inghiottito dal gorgo ricomparve
aggregandosi a sciami d’altre vele:
palpitarono prima di svanire
nell’oro fuso e tremulo del mare.
Martellando la riva, ci assediava
l’onda incalzante in impeti d’ariete,
un colpo dopo l’altro, poi la tregua
per riprendere lena e ritentare
la corsa vana e folle dell’assalto
rotta in trine di spuma evaporate
nell’ardore del sole, come sogni.
Io ti cercavo lungo l’arenile,
le mie orme seguivano le tue,
cancellate dai flutti le perdevo
per ritrovarle ancora più profonde.
Allacciava l’amore sulla rena
la mia ombra fedele con la tua:
era così l’estate che passava.
LA CASA DI LIVIA
Il vento piega
il sistro
dell’acànto fiorito
senza voce;
ali distanti solcano la sera
bruciandosi nel sole.
Alla casa di Livia
ho visto donne
paludate di porpora
e di bisso
muoversi lievi
in freschi peristili
portando rose e glicini
a ghirlande,
altre colmare d’olio
le lucerne
proteggendo la fiamma
con la mano
resa d’opale al gioco
della luce.
Ho udito l’arpa
unirsi alla tua voce
e la fontana
far da contrappunto
all’arcano vibrare delle note.
Questa, mia dolce amica,
è la stagione
in cui l’acànto mette fiori
e piega
al vento della sera
il sistro muto.
MATTUTINO
(Orti di Numa)
L’ultimo biancospino annuncia il tempo
che rende il clivo orfano del tenue
candore immacolato del suo fiore.
Ma risorge la viola a coronare
gli archi sorretti dalla pietra stanca
di numerare i giorni e le stagioni.
Nella sua carne scava nidi il marmo,
dei segni riscattando la superbia,
gloria fugace, labile memoria.
Così l’alloro, che adornò la fronte
di vati e bardi, dà pastura ai merli
in umiltà di semi e nere bacche,
il fico ruminale tregua d’ombra
a rettili ridesti dal letargo.
Null’altro resta, ma se plachi il cuore,
dai giardini di Numa, per magia,
ti giunge il melodiar delle Camène.
SEGESTA
Quando canti profani e umane voci
e le cornacchie a stormi taceranno,
da folti boschi di cipressi e pini
un flauto lieve desterà la luna
facendola salire alta nel cielo:
come l’incantatore quando ammalia
con suoni astuti l’aspide o la serpe.
O sarà il vento, che tra cedri e ulivi
l’arpa percorrerà con le sue dita
traendo canti di memoria antica
e nuovi ne ricavi dalle foglie,
da tronchi e rami roridi d’argento.
Domani andranno greggi tra le pietre,
tracce di gloria umana ora assopita,
e nessun flauto la potrà svegliare.
BEATITUDINI
Noi dureremo. Lo promise un giorno
l’Uomo che predicò sulla montagna
a gente scalza, nuda e senza pane.
« Non dubitate – disse – il Regno è vostro.
Voi che patite l’onta e la miseria
governerete il mondo, vi assicuro ».
Era un giorno d’aprile, forse maggio,
e l’Uomo usava inedite parole.
« In verità vi dico, il tempo è giunto,
quando l’agnello vincerà il leone,
il povero avrà troni a ricompensa
e pace verrà data a chi la vuole ».
Fremevano le folle e il vento lieve
spargeva come semi le parole
riconfortando i cuori inariditi,
simili a zolle avide di pioggia:
« Colui che è primo cederà il suo posto
agli ultimi del giro, e chi possiede
vedrà passare ad altri i suoi tesori.
Chi subisce la sferza avrà sollievo ».
Così parlava l’Uomo e le Sue vesti
splendevano di luce come un sole
venuto a riscaldare i derelitti.
« Voi che soffrite fame di giustizia
riceverete cibo in abbondanza,
voi che subite iniquità tacendo
avrete i vostri nomi scritti in Cielo
sul Libro della Vita, e chi ferisce
si smarrirà nel vortice del nulla ».
Promise questo l’Uomo, ed era maggio,
o forse il tempo di stagioni attese,
ogni parola percorreva l’aria,
colomba con il segno dell’ulivo.
« Beato chi non ha scienza e favella,
chi la speranza perde e si smarrisce:
lo Spirito darà verbo e sapienza
e lumi nella notte per andare.
E durerete, in verità vi dico ».
Così ci fu promesso. E dureremo.
SPERANZA
Il mare tornerà, tornerà l’erba,
porteranno coralli e fioriture,
avranno voli i nidi di cemento,
e primavere le città perdute
negli inquieti deliri senza luce.
Tornerà l’onda, torneranno i prati
con lucciole pulsanti nella notte,
con iridi fluttuanti di farfalle,
s’abbelliranno il capo le sirene
con trine d’alghe e boccole di perle.
Il canto tornerà, tornerà il tempo
d’inneffabili cose barattate
coi poteri di Mida, e crolleranno
le Torri di Babele che l’orgoglio
eresse per raggiungere le stelle.
E torneranno i Numi nel giardino
dove da creta diventammo carne,
i nostri giorni non declineranno,
le rose non avranno mai più spine,
risplenderanno gli occhi senza pianto.

