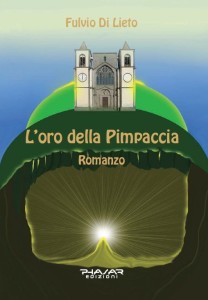
Ed. Phasar – 2015
Un amore interrotto secoli prima e un progetto sociale realizzato a metà trovano compimento grazie a un tesoro dissepolto: l’oro della fraternità.
Ci sono momenti critici nella storia degli individui, dei popoli, delle civiltà, che solo un prodigio può risolvere. Il protagonista, Giovanni Papasia, ne realizza uno risolutivo, globale, in coppia con una giovane donna, in tempi diversi sibilla, regina, papessa, infine portatrice dell’oro che salverà il mondo.
Coincidenze
Start up
Una delusione
Foto rivelatrici
La fuga della Pimpaccia
La visita a San Martino
L’incontro
Blitz notturno per un allarme
Un appuntamento
Déjà vu
Il video
Una strana storia
Un diario esplicito
Il segreto
La discesa nel tunnel
Un invito a pranzo
L’ombra della sera
L’eterno femminino
Il sensitivo
Sull’Isola Tiberina
La sibilla
Credere e conoscere
Il Monte di Pietà
Moccoli e candele
Un minerale dell’altro mondo
Una proposta
Al bar della palma
Dimissioni
Una nuova vita
Primi passi organizzativi
Una buffa vetturetta
Il mondo sotterraneo
Il magico bastone
Coppedè e dintorni
Visita alla miniera
Il Progetto Sibilla
Verso l’Abruzzo
A Luco
Il rituale
Il grandioso progetto
Il potere occulto si difende
Natalucci se ne va
Bilderberg de noantri
Alfa e Omega
Un idealista e i suoi discepoli
I Guardiani della Botola
Le risorse del bene
Offshore
A Vaduz
Redenzione e rinascita
Qualche mese dopo
Fumo di Londra
Dalla fine il principio
Il fantasma del Museo
Il museo Doria aprí puntuale alle dieci e accolse i visitatori dell’associazione belga Croire et Connaître. Erano guidati dalla capogruppo, una bionda esile sui trenta con in mano la classica bandierina di richiamo del gregge. La ragazza pagò gli ingressi e il gruppo passò ordinatamente e in silenzio i tornelli, sparpagliandosi poi nelle varie sale. Non era prevista la visita guidata, poiché ogni sala era dotata di apparecchi audiovisivi che davano spiegazioni sulle opere esposte nelle quattro lingue canoniche europee, oltre a russo, cinese e giapponese. Intanto altri visitatori erano entrati, tra questi appunto gli immancabili giapponesi, armati di guide e sofisticati apparecchi digitali per video e foto, per riportare in patria piú dettagli possibili di quanto avrebbero visto e udito nel corso di tour intensivi, pieni zeppi di città, monumenti, scorci di paesaggi, visioni naturali, happening imprevedibili, possibili però in Italia.
Fu proprio un happening imprevisto quello che si verificò nella sala che ospita il busto di papa Innocenzo X Pamphilj. A un certo punto una donna si fece rapidamente largo tra i visitatori, si avvicinò al busto marmoreo del papa e dopo aver deposto sul piedistallo una rosa baccarat, abbracciò l’erma severa del pontefice con un trasporto lungo e intenso, come se si fosse trattato di una persona in carne e ossa. Poi, cosí come era apparsa, eterea e frusciante, la figura femminile si dileguò.
Benché evanescente e rapida, metafisica e indefinibile, l’apparizione fece una vittima fisica nella persona di un’anziana turista del gruppo belga, Annette Dugros. La misteriosa, elusiva presenza in fuga, passandole vicino, la penetrò con uno sguardo inquietante, quindi, dopo averla sfiorata, scomparve lungo il corridoio che portava all’uscita, lasciandosi dietro un vago sentore di essenze floreali, tra cui spiccava, disse la turista, quella di lavanda o violacciocca. Un profumo che l’aveva pervasa come quegli occhi magnetici, e lei ne era rimasta quasi incantata, tanto che avevano dovuto faticare a portarla fuori.
I presenti e gli altri componenti della comitiva finirono con il concludere che la donna fosse l’ennesima vittima della Sindrome di Stendhal: il gruppo di Croire et Connaître in tre giorni di permanenza a Roma aveva infatti già visitato i Musei Vaticani, Palazzo Barberini, la Galleria Corsini, oltre a varie chiese dove si trovavano opere famose di pittura e scultura. Evidentemente, c’era stata una saturazione ottica ed emotiva.
Che il comportamento della turista belga non fosse però solo una patologia neurologica fu confermato da ciò che accadde subito dopo nel Museo: alcune ragazze giapponesi in visita corsero fuori e dal fioraio del Collegio Romano acquistarono delle rose rosse che deposero sotto il busto di Innocenzo X, dopo aver pagato un nuovo biglietto d’entrata. L’episodio animò i telegiornali della sera e i quotidiani lo registrarono per darne notizia l’indomani.
Coincidenze
Gianni uscí sul terrazzino del roof garden al piano attico del lussuoso hotel di Via Veneto. Indossava una vestaglia di raso rosso granata, stretta in vita da un cordone in tinta, e stava sorbendo un caffè che gli aveva appena portato Nicola, il cameriere del room service, insieme a due brioche, una spremuta di pompelmo e il quotidiano locale. Dalla chiesa di Sant’Isidoro, di rito irlandese, venivano le voci del mattutino dei frati, smorzate dalla distanza, insieme al tubare dei piccioni sulle antiche gronde di Via della Purificazione.
In Via degli Artisti, al numero 15, si aprí la finestra del terzo piano e una mano rugosa sparse granaglie sul davanzale. I piccioni interruppero le loro effusioni e si calarono frullando con la dignità e il distacco di uccelli acquartierati in una delle enclave piú esclusive della Roma mito-folklorica.
Sporgendosi alquanto dal parapetto di maiolica di Faenza e cotto fiorentino, Gianni riuscí a scrutare il tratto di Via Veneto che dall’hotel portava a Piazza Barberini. Sotto i rameggi diradati dei grandi platani ormai ultrasecolari, essendo stati piantati dopo Porta Pia, riusciva a scorgere i gazebo e gli ombrelloni dei caffè e dei ristorantini, i tavolini assiepati per sfruttare al massimo lo spazio concesso dal Comune, fatto pagare a caro prezzo, per non parlare delle multe.
Ma queste miserie contabili svanivano nell’aura da perenne Dolce Vita che la piú blasonata strada romana offriva a ogni ora e stagione. Dai sotterranei della metro, il buio vomitava folle di impiegati e studenti, che andavano a buttarsi nel tritacarne della sopravvivenza precaria. Sentí riecheggiare nella mente i versi dell’Inferno dantesco «…si’ lunga tratta / di gente, ch’i’ non averei creduto / che morte tanta n’avesse disfatta». Morti viventi, zombi prodotti da una civiltà che li alloppiava con surrogati edonistici, per abusarne.
E i turisti? Tanti, già a quell’ora del giorno, avidi di sorprese e di happening. Erano seduti composti e garruli, chi per il caffè o il cappuccino, ormai diventato “mocaccino” per via di un travisamento tutto americano, chi per il gelato, chi per una di quelle pizze che solo i locali per turisti riescono a imbastire, secondo partiture gastronomiche ignote e audaci, con combinazioni e ingredienti da laboratorio del Dottor Mabuse. Un giorno non lontano, qualche ricercatore di biochimica scoprirà che certe pizze, in virtú di imprevedibili combinazioni di ingredienti, hanno debellato malattie inguaribili.
Osservando con maggiore attenzione, Gianni non poteva non notare altri turisti che sul lato opposto della strada andavano a visitare il cimitero dei Cappuccini, resti di ossa composte in maniera teatrale, un tentativo di esorcizzare la morte. E ci riuscivano, i frati. Quelli che uscivano dalla chiesa ridevano e scherzavano, come se avessero assistito a uno spettacolo comico. Potere della scenografia e della morte resa spettacolo.
Pensieri dissacratori gli attraversavano la mente: vedeva il Giorno del Giudizio e tutti gli scheletri dei frati ricomporsi secondo quanto previsto dalle Scritture, lasciare la cripta dei Cappuccini rimpannucciati e reincarnati, e sciamare festosi lungo la doppia scalinata invadendo Via Veneto, saggiare de visu e de corpore quegli umori della mondanità che erano stati loro negati per secoli ma di cui avevano sentito decantare le ebbrezze, vietate a monaci e trapassati.
Accorgendosi però di sfiorare la blasfemia, Gianni si costrinse a ricacciare indietro quelle immagini irriverenti. Gli capitava sempre piú spesso di costruire trame e immagini fantastiche, senza che se ne rendesse conto. La voglia di inventare situazioni e personaggi gli era diventata fisiologica, e non se ne curava piú. Anni prima, uno psicologo che lo aveva controllato per conto della compagnia aerea per la quale lavorava, lo aveva messo in guardia dall’elaborare storie inventate, e di fare agire soggetti nell’astratto. C’era una soglia, gli aveva detto, oltre la quale si apre una dimensione imprevedibile, in cui tutto è possibile. Ma poi aveva letto una poesia bella e tremenda di Dylan Thomas, il bardo gallese che quella soglia aveva superato tante volte ed era ritornato carico di forze inesprimibili, semidivine. «E la morte non vincerà. Saremo folli e ottusi come chiodi, ma la morte non vincerà!» diceva la poesia. E lui andava e tornava da quella dimensione oltre, quasi un eroe. Quando ritornava, trovava Roma piú sublime che mai, a ricordargli che la vita reale vira in favola.
Visto cosí, avvolto nella sua vestaglia sontuosa, la tazzina del caffè graziosamente tenuta con due dita e poi mollemente deposta sul vassoio, le brioche prelevate dal piattino decorato e addentate con la grazia dell’uomo satollo e ligio ai precetti di Monsignor Della Casa, Gianni poteva passare per un ricco snob allocato in uno dei loft piú esclusivi dell’hotel, pronto a tuffarsi nel gran mare della città quirite, con i suoi negozi dalle grandi firme, con le cocotte a spasso lungo Via Veneto, giú fino al Popolo e Ripetta, seguendo la passeggiata del giovane Sperelli, ardente di piaceri da consumare, giú dal Pincio per la Scalinata di Piazza di Spagna. Ma era tutto un bluff, una messa in scena: il trentasettenne Gianni Papasia era in forza presso la portineria dell’hotel come addetto al banco, al telefono e come operatore plurilingue. Il terrazzino faceva parte della foresteria che l’hotel metteva a disposizione dei dipendenti fuori sede, gratuitamente, oltre all’alloggio, alla mensa e al servizio di lavanderia. Cosí, il giovane Gianni Papasia aggirava la crisi grazie a una coincidenza significativa, per dirla con Jung, o meglio, per dirla con il professor Natalucci, la giusta carrettella presa al volo.
Ripensandoci, non poteva escludere una coincidenza karmica nel suo incontro con Natalucci. Non l’aveva conosciuto nella pensione dove abitava ma in una chiesa, esattamente nella parrocchia di Piazza Salerno, una domenica mattina, durante la messa delle sette. Era disperato. Dopo l’attentato alle Torri Gemelle, le compagnie aeree erano entrate in fibrillazione e molte avevano chiuso gli uffici a Roma, sospeso i voli, trasferito le sedi a Londra o altrove in Europa. Erano passati sei mesi dal licenziamento per giusta causa e lui aveva bussato a tutte le porte per essere riassunto. Nulla da fare. La liquidazione che aveva ricevuto era agli sgoccioli. Ancora un mese e non avrebbe piú potuto pagarsi il monolocale con ingresso indipendente in via Musa, proprio dietro la chiesa di Piazza Salerno. Lí aveva condotto per un paio d’anni una vita da scapolo d’oro, invitando amici e colleghi per un drink, una spaghettata, e soprattutto ricevendo Martina Zimmerbruck, la tirolese giunonica e disinibita che lavorava al Goethe-Institut. La nave della bohème stava affondando, lo champagne aveva ceduto il posto al Frascati, e per questo la bionda e prorompente Martina aveva scelto lo sbarco. L’aveva incontrata un mese dopo, in compagnia di un pittore napoletano, basso e pingue, che però aveva un appartamento ai Parioli e la erre moscia, che faceva tanto nobiltà borbonica, e che a lei, provinciale tirolese, piaceva molto…

